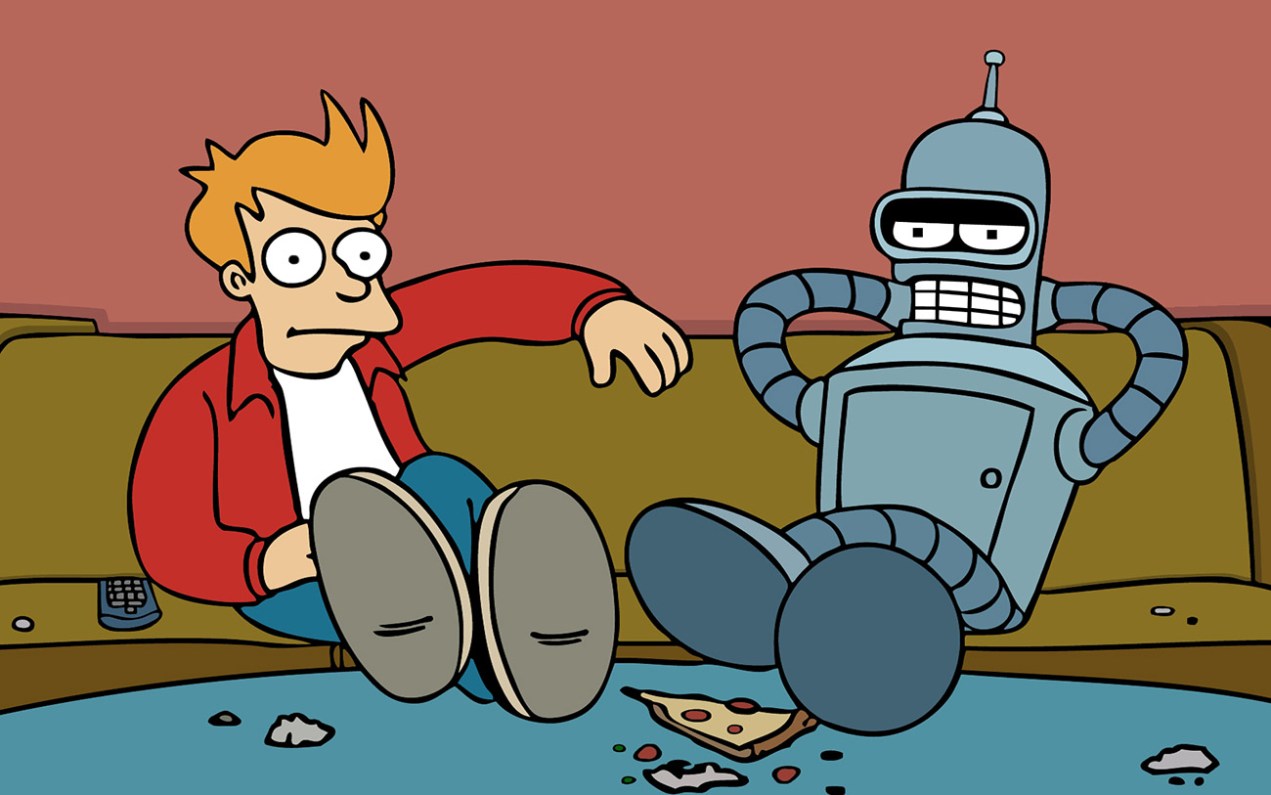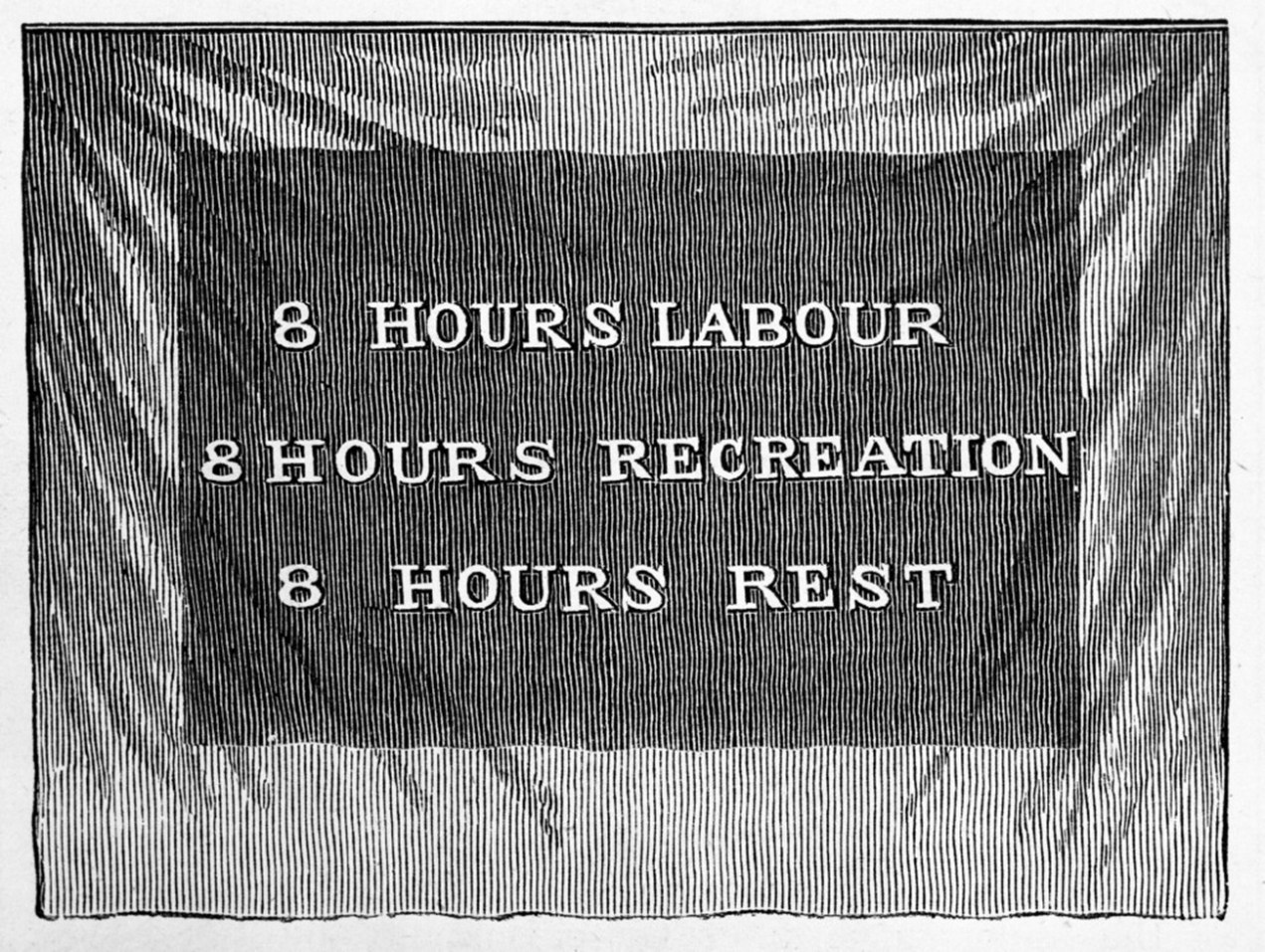Il celebre poemetto del medico e saggista olandese Bernard de Mandeville (1670-1733), La favola delle api ovvero, vizi privati pubblici benefici giunge nel 2014 a 300 anni e il Sole24Ore del 2 marzo 2014 dedica all’opera un approfondimento.
giunge nel 2014 a 300 anni e il Sole24Ore del 2 marzo 2014 dedica all’opera un approfondimento.
Non a tutti è noto che il saggio – del 1714 – venne preceduto di qualche anno da uno scritto, sempre in forma di poema satirico, legato a circostanze molto specifiche e non ancora dotato del significato allegorico universale proprio dell’opera più celebre.
Mandeville, trasferitosi a Londra nel 1699, si trovò catapultato all’interno di una polemica fra Tory e Whig che animava il dibattito politico di quegli anni. Oggetto della disputa erano le campagne militari condotte da John Churchill (1650-1722), duca di Marlborough. I Tory accusavano Churchill e in generale i suoi sostenitori Whig di essersi arricchiti grazie alla guerra, insinuando al tempo stesso che l’intero sistema di finanza pubblica, incentrato sulla Banca di Inghilterra, non fosse che un apparato corrotto a uso e consumo dei Whig.
Queste dunque le circostanze che ispirarono il saggio del 1705 di Mandeville, The Grumbling Hive, or Knaves Turn’d Honest (L’alveare scontento, ovvero i furfanti divenuti onesti). Fin da questo primo scritto, lo scopo di Mandeville è quello di mostrare, con gli strumenti dell’allegoria e dell’ironia e senza prendere posizioni, che guerra, corruzione e interessi personali rappresentano un prezzo da pagare per un’economia interna rigogliosa e un governo stabile. Questi principi torneranno dunque nel 1714, rielaborati e ampliati, nella celebre Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits. Per celebrarne la memoria e l’attualità, vale la pena di estrarne un celebre passaggio.
«Essendo così ogni ceto pieno di vizi, tuttavia la nazione di per sé godeva di una felice prosperità, era adulata in pace, temuta in guerra. Stimata presso gli stranieri, essa aveva in mano l’equilibrio di tutti gli altri alveari. Tutti i suoi membri a gara prodigavano le loro vite e i loro beni per la sua conservazione. Tale era lo stato fiorente di questo popolo. I vizi dei privati contribuivano alla felicità pubblica […]. Le furberie dello stato conservavano la totalità, per quanto ogni cittadino se ne lamentasse. L’armonia in un concerto risulta da una combinazione di suoni che sono direttamente opposti. Così i membri di quella società, seguendo delle strade assolutamente contrarie, si aiutavano quasi loro malgrado».
[ illustrazione: particolare dalla locandina del film di Irwin Allen del 1978 The Swarm, che narra di un’invasione di api killer in Texas ]