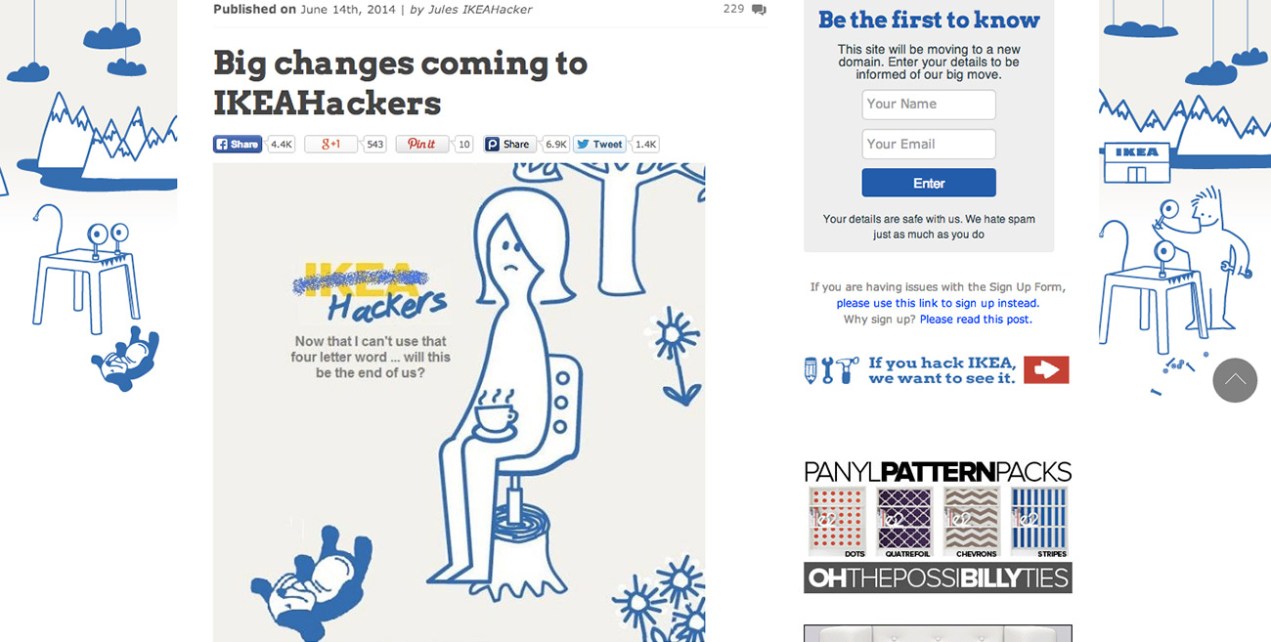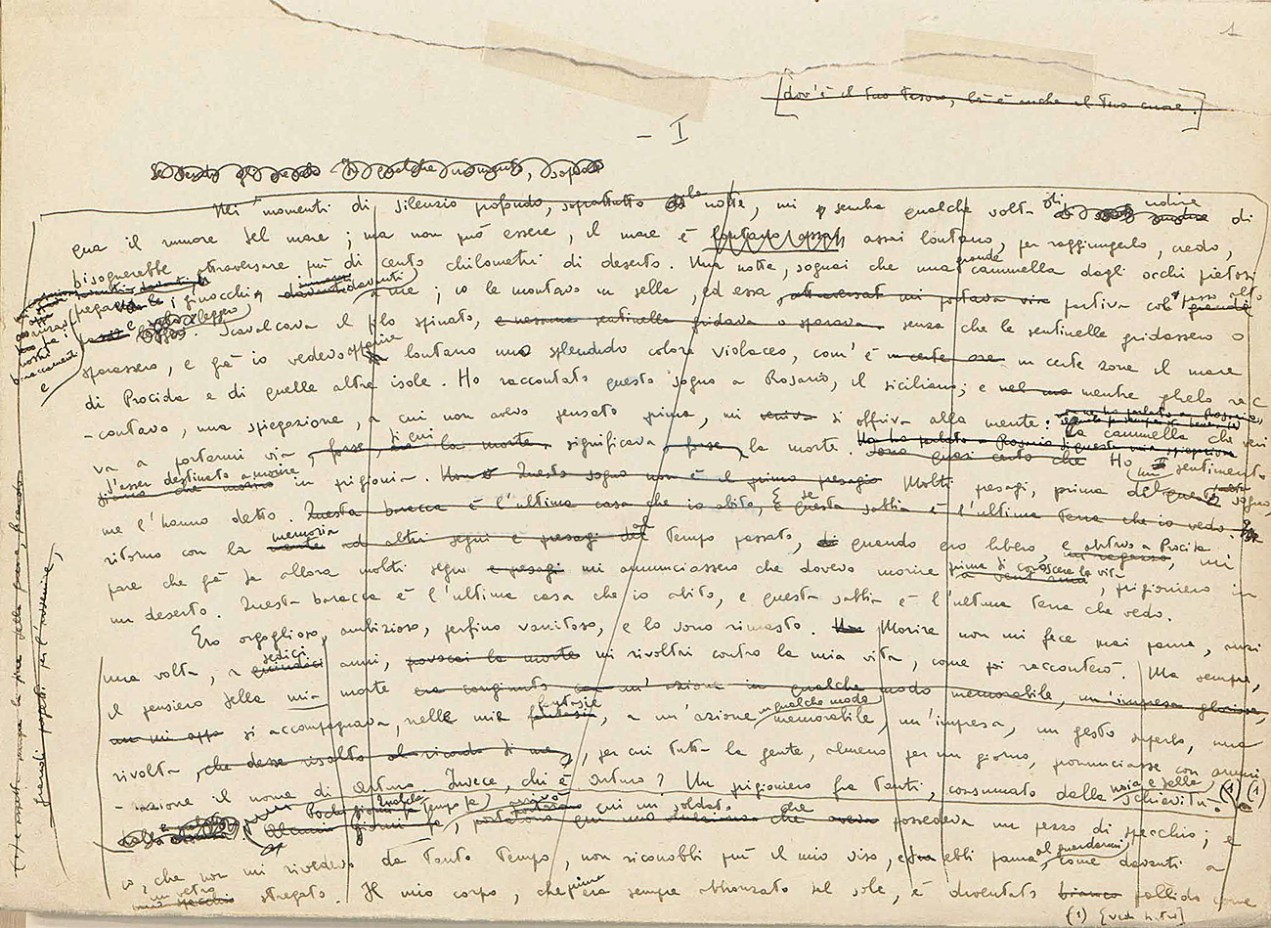«Il problema della democrazia è quello di come rendere la nostra vita quotidiana creativa».
Mary Parker Follett
Su Wikipedia ancora nessuno ha pensato di aprire una pagina in italiano dedicata a Mary Parker Follett (1868-1933). Questo particolare la dice lunga sulla scarsa fama di cui gode in Italia questa pensatrice americana, il cui contributo è stato centrale per lo sviluppo del pensiero manageriale delle origini. Il confronto con la psicologia comportamentale e con quella della Gestalt permisero a Follett di elaborare un pensiero originale nel quale le logiche funzionalistiche e gerarchiche dell’organizzazione del lavoro sono rilette secondo una dinamica di valorizzazione dell’elemento umano che anticipa – e per molti versi supera – diversi elementi tematizzati dallo Human Resources Movement.
Il suo testo Esperienza creativa (1924) offre una lettura del tema della creatività di grande valore civile. Anzitutto, creatività non è cosa individuale ma relazionale. Il discorso di Follett sulla creatività è collettivo e sociale, ponendosi come presupposto per una vera democrazia. La creatività è integrazione di diversità e il tema della responsabilità e del confronto non sta nella risposta di un soggetto A a un soggetto B, ma nella relazione fra A, B e il contesto in cui entrambi si muovono. Tutti questi elementi sono dinamici, in continuo cambiamento. La loro relazione non avviene tramite un’entità astratta come la “mente”, ma in concreto, nel mondo, attraverso relazioni fisiche e motorie. La pratica della creatività è il processo di integrazione che scaturisce da questo incontro.
Follett dedica diverse pagine del suo saggio a un tema centrale per le organizzazioni contemporanee e più in generale per la società, quello del ruolo dell’esperto. La cieca fiducia che spesso viene conferita a chi è ritenuto in possesso di una conoscenza “esperta” rappresenta una delegittimazione della relazione di corresponsabilità e, di conseguenza, delle dinamiche alla base della creatività. Il presupposto erroneo di questo tipo di considerazione sta nel ritenere i fatti immutabili e le posizioni dell’esperto assolute. Ma, coerentemente con la dinamica di integrazione esposta da Follett, i fatti non potranno mai essere statici, né le interpretazioni oggettive. L’esperienza delegata non potrà mai prendere il posto di un’esperienza vissuta relazionalmente, dialetticamente. Ecco perché un’educazione al “buon uso” degli esperti, nei confronti dei quali il tema centrale è di nuovo quello del dialogo e dell’integrazione, è un presupposto fondamentale per una effettiva democrazia, tanto in ambito sociale quanto lavorativo.
[ illustrazione: Henry Matisse, La tristesse du roi, 1952 ]