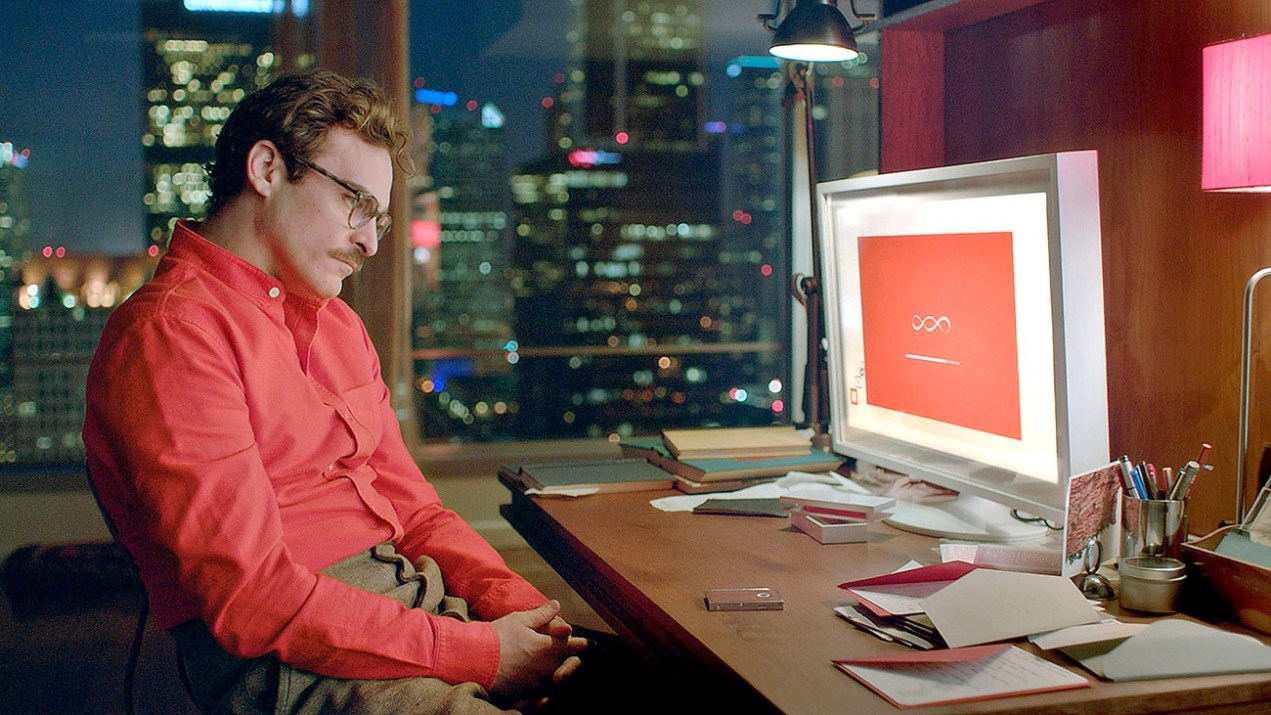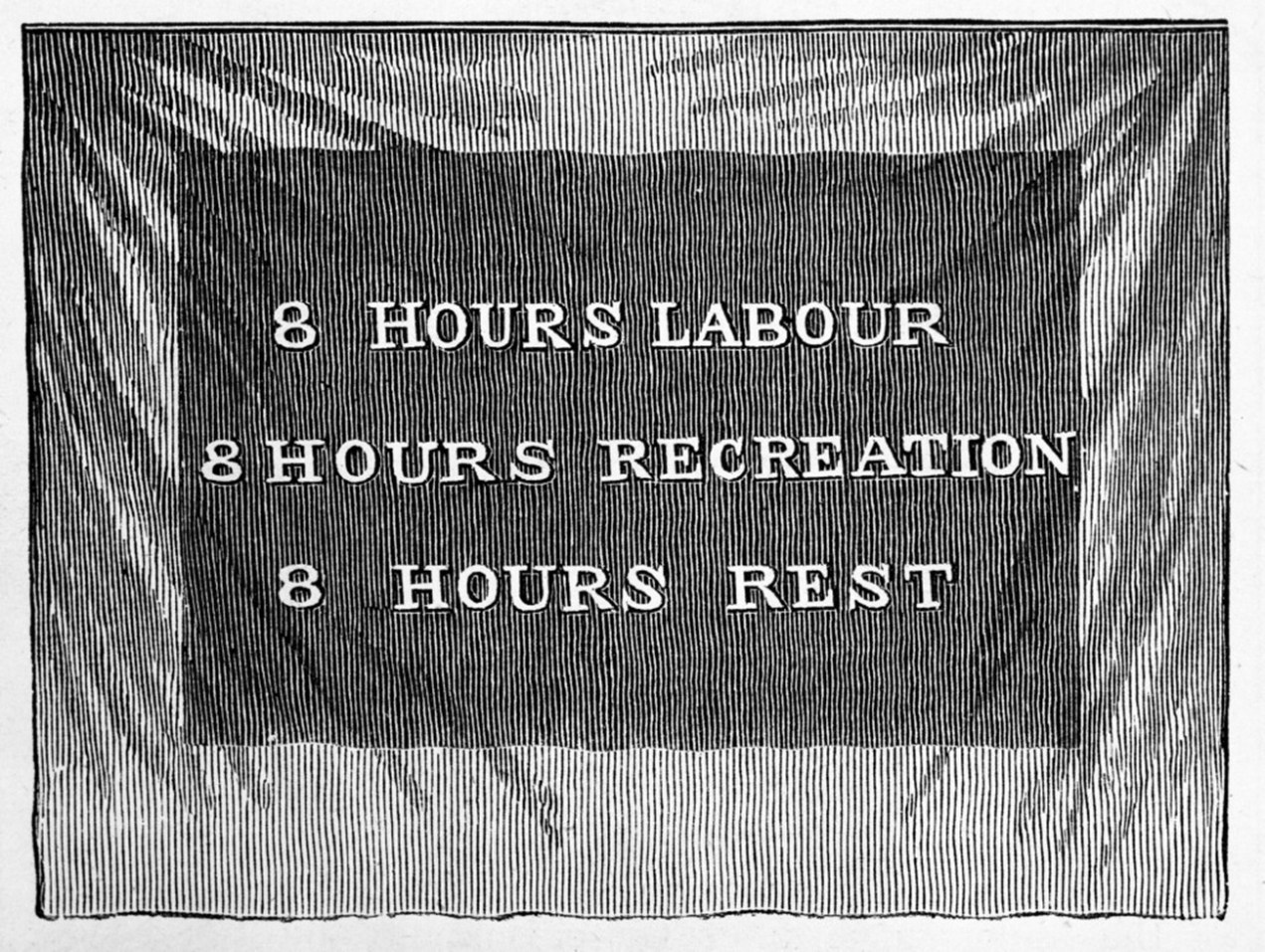Che I 400 Colpi (1959) di François Truffaut sia uno dei capolavori della storia del cinema è cosa nota. Altrettanto noto è il fatto che il protagonista Antoine Doinel – destinato a “crescere” nei successivi film di Truffaut – sia sotto molti punti di vista un alter ego del regista. Truffaut è effettivamente stato un “cattivo ragazzo”: cresciuto in strada, dedito al furto e alla menzogna, ha anche conosciuto in più occasioni l’esperienza del carcere.
La curiosa tesi presentata da un recente articolo della rivista «Open Culture» è la seguente: se Truffaut fosse cresciuto come un “bravo ragazzo”, probabilmente non sarebbe diventato un regista così eccezionale. L’indole che nel Truffaut ragazzo poteva essere bollata come “ambiguità morale” portava in sé i tratti centrali della grandezza del futuro regista, cioè la tensione a oltrepassare le regole, lavorare ai confini, essere guidato da un’urgenza personale disposta a scendere a pochi compromessi. Il suo stesso portare la cinepresa in strada – atto destinato a diventare cifra stilistica della Nouvelle Vague – può forse dirsi conseguente alla sua esperienza di vita fuori dai canoni tradizionali. In altri termini: una crescita caratterizzata da scarsa omologazione (portata nel caso di Truffaut fino alle sue estreme conseguenze) può condurre – per dirlo in linguaggio aziendale – a una maturità caratterizzata da forti tratti di auto-motivazione e capacità innovativa.
L’analisi di «Open Culture» va oltre, fino a chiamare in causa le competenze di gestione economica mostrate dal regista nel corso della sua carriera. L’indipendenza sempre cercata da Truffaut, nonché la sua precoce scelta di aprire una propria casa di produzione cinematografica, sarebbero frutto di uno spirito imprenditoriale coraggioso, nuovamente riconducibile a un’infanzia in cui la sopravvivenza materiale ed economica era stata messa quotidianamente a rischio. Imparare a vivere alla giornata e ad adattarsi al contesto produrrebbe dunque manager più concreti e audaci anche dal punto di vista della gestione delle risorse e dell’assunzione di rischi.
Tutte tesi interessanti, non facili da mettere alla prova con casistiche reali. Di certo, guardare i film di Truffaut non può che giovare all’apertura mentale di qualsiasi manager.
[ illustrazione: fotogramma dal film Les Quatre Cents Coups di François Truffaut, 1959 ]