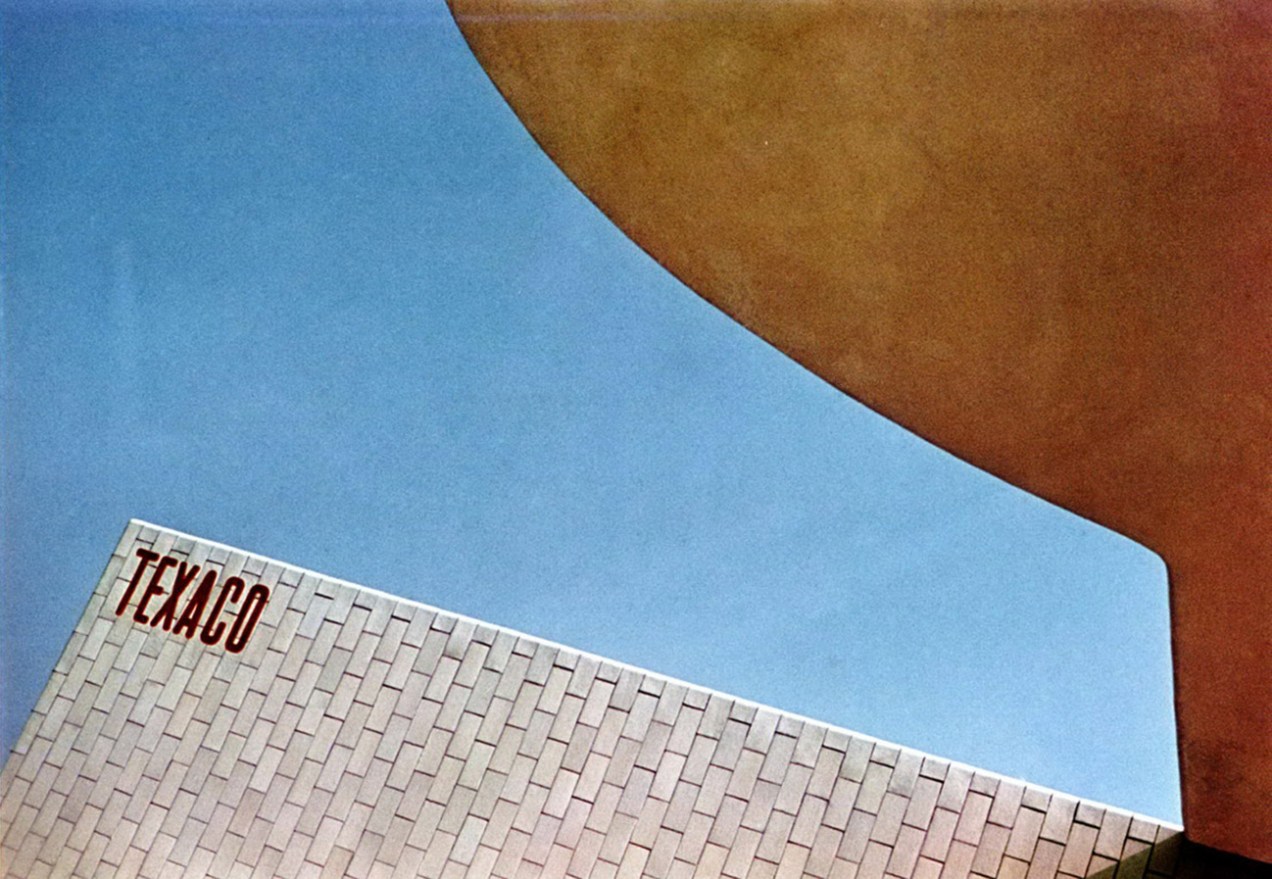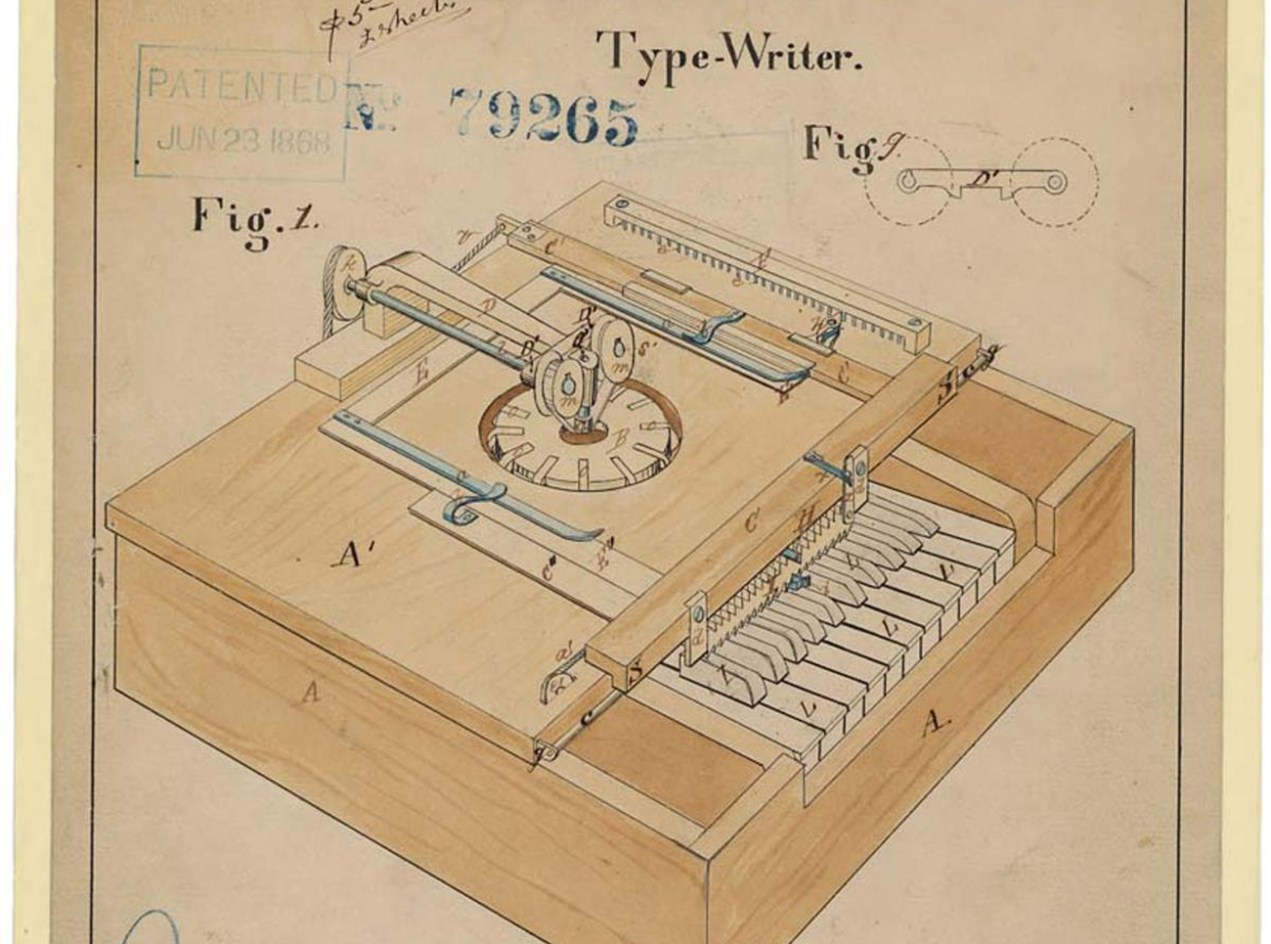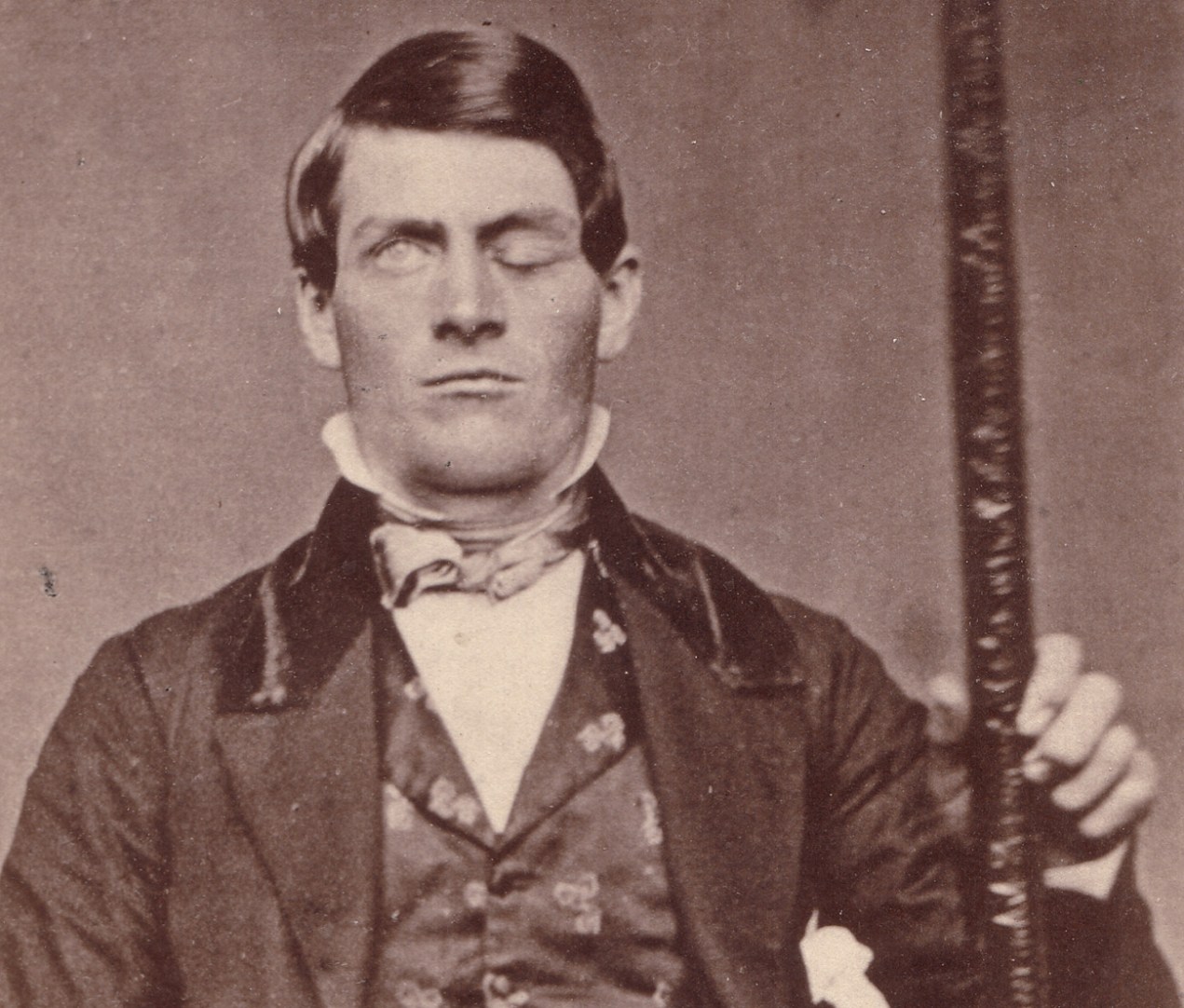«Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose: dove va, cosa fa, dove è stata».
Dal film Forrest Gump, 1994.
Se la massima della madre di Forrest Gump può essere mai stata presa davvero sul serio da qualcuno, in cima alla lista dei sospettati compare il nome dell’australiano Ian Fieggen, ex programmatore e per gli amici “professor lacci da scarpe”.
Allacciarsi le scarpe è un gesto tanto quotidiano quanto automatico, di norma oggetto di ben poca riflessione. Tuttavia, se è vero che “il diavolo è nei dettagli”, delle stringhe ben allacciate possono fare la differenza. O almeno questo è quanto deve aver pensato Fieggen: secondo la leggenda – ovviamente alimentata da lui stesso – è stato un laccio spezzato nel 1982 ad aver dato vita alla sua missione, cioè quella di mettersi in cerca del nodo per scarpe perfetto. Nel corso degli anni Ian ha individuato ben 41 modi per stringare le scarpe e 18 per fare il nodo, tutti accuratamente descritti nel suo sito web , lanciato nel 2000 e a oggi visitato da circa 9000 persone al giorno.
A ben vedere, a Ian – che è anche autore di un libro (ovviamente intitolato Laces) e di una app per iPhone – non pare interessare tanto il lato estetico dell’allacciarsi le stringhe, quanto quello funzionale. «I’m passionate about efficiency», dichiara nel suo sito, e riprova di questo spirito, da vero taylorista delle calzature, ha frazionato il processo dell’allacciarsi le scarpe in sei diversi step. Non contento di questo traguardo, Ian ha trovato il modo di rendere questi step tre volte più veloci, mettendo a punto un nodo rivoluzionario indicato come “Ian’s knot”, niente meno che il modo per allacciarsi le stringhe più veloce ed efficiente del mondo. A fronte di questo successo, Ian ha solo un cruccio: quello di non essere stato ammesso al Guinness dei primati. Pare infatti che la sua disciplina sia stata valutata un po’ troppo specialistica.
[ illustrazione: fotogramma dal film di Robert Zemeckis Forrest Gump, 1994 ]