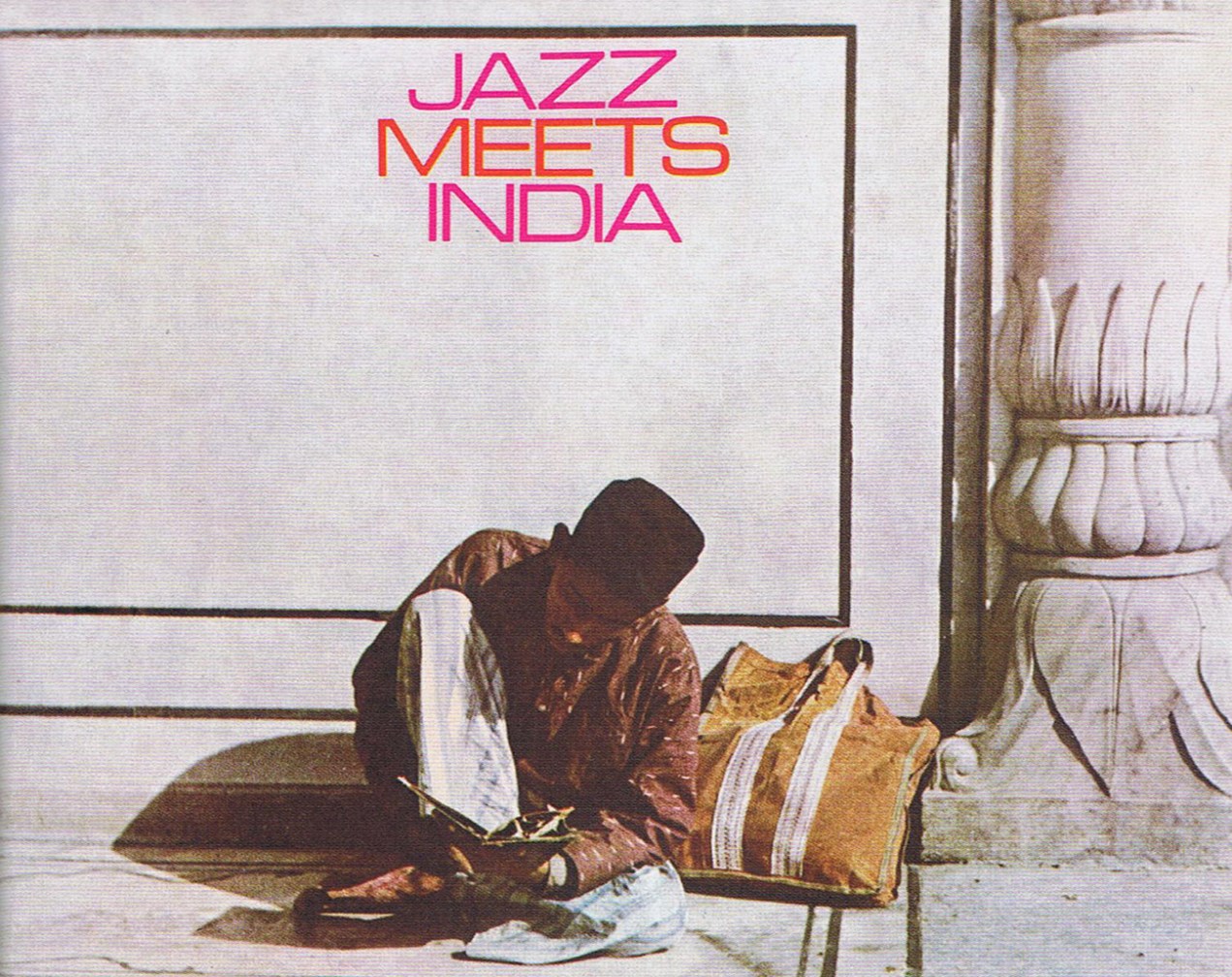«Il diciottesimo secolo ha abbracciato l’idea di progresso; il diciannovesimo quella di evoluzione; il ventesimo quelle di crescita e innovazione. La nostra era ha prodotto la “disruption”, atavica a dispetto del suo mostrarsi futuristica. È una teoria della storia fondata su una profonda ansietà per un collasso finanziario, su una paura apocalittica di una devastazione globale».
Il quadro costruito da Jill Lepore, contributrice del «New Yorker», non può dirsi rassicurante. A diciassette anni dalla pubblicazione di Il dilemma dell’innovatore di Clayton M. Christensen, l’innovazione “disruptive” (improprio tradurla con “dirompente”) è una delle religioni più diffuse nel mondo del business. Professata – più di rado praticata – da orde di fedeli, è riconducibile al filone ideologico dell’innovazione come fine e non come mezzo.
Fra gli adepti, pochi realizzano che l’origine della disruption è di natura negativa. Il dilemma dell’innovatore è quello del fare la cosa giusta al momento sbagliato: la storia è troppo veloce, il cambiamento incalza, i più restano indietro. Chi sopravvive, guida il cambiamento. Le sue innovazioni, se guardate retrospettivamente (come del resto ogni successo, participio passato del verbo succedere), passano alla storia come radicali, dirompenti. Questo, per sommi capi, il pensiero di Christensen.
Il concetto di “disruption” altro non è che una rimasticatura in salsa americana della “distruzione creatrice” teorizzata fin dal 1942 da Joseph Schumpeter. Quanto Christensen vi aggiunge – suffragato da casi studio di cui l’articolo di Jill Lepore mette in luce una certa pretestuosità – è un’indole di spietatezza che antepone il successo a qualsiasi regola, responsabilità e sostenibilità di lungo periodo. Non è casuale l’esempio citato da Lepore in proposito: quando l’industria finanziaria si è messa a innovare in maniera disruptive, ha generato una crisi globale. E tuttavia, proprio come lo scoppio della bolla delle dot.com, la crisi non ha sedato le attitudini disruptive ma le ha rinfocolate. Mostrando tutta la ricorsività di un’ideologia il cui principale alimento è la paura.
[ illustrazione: Free Universal Construction Kit ]