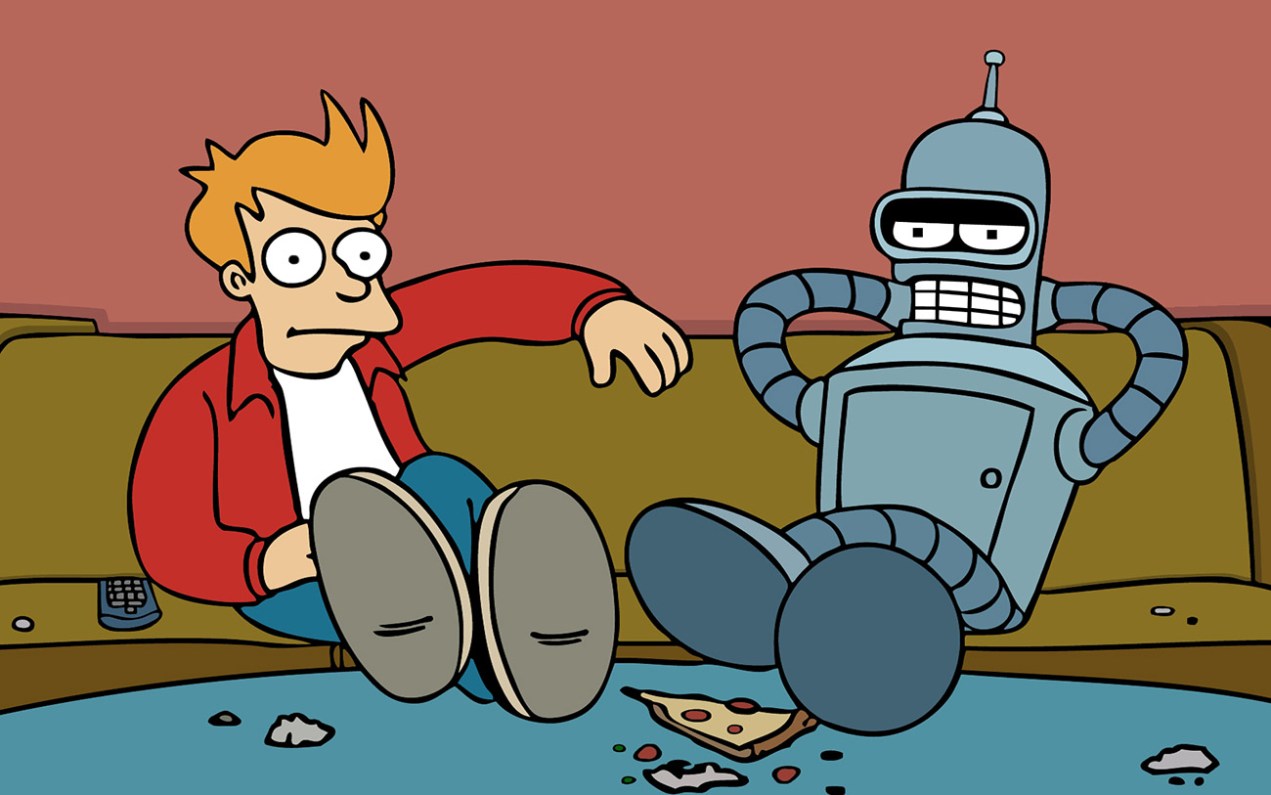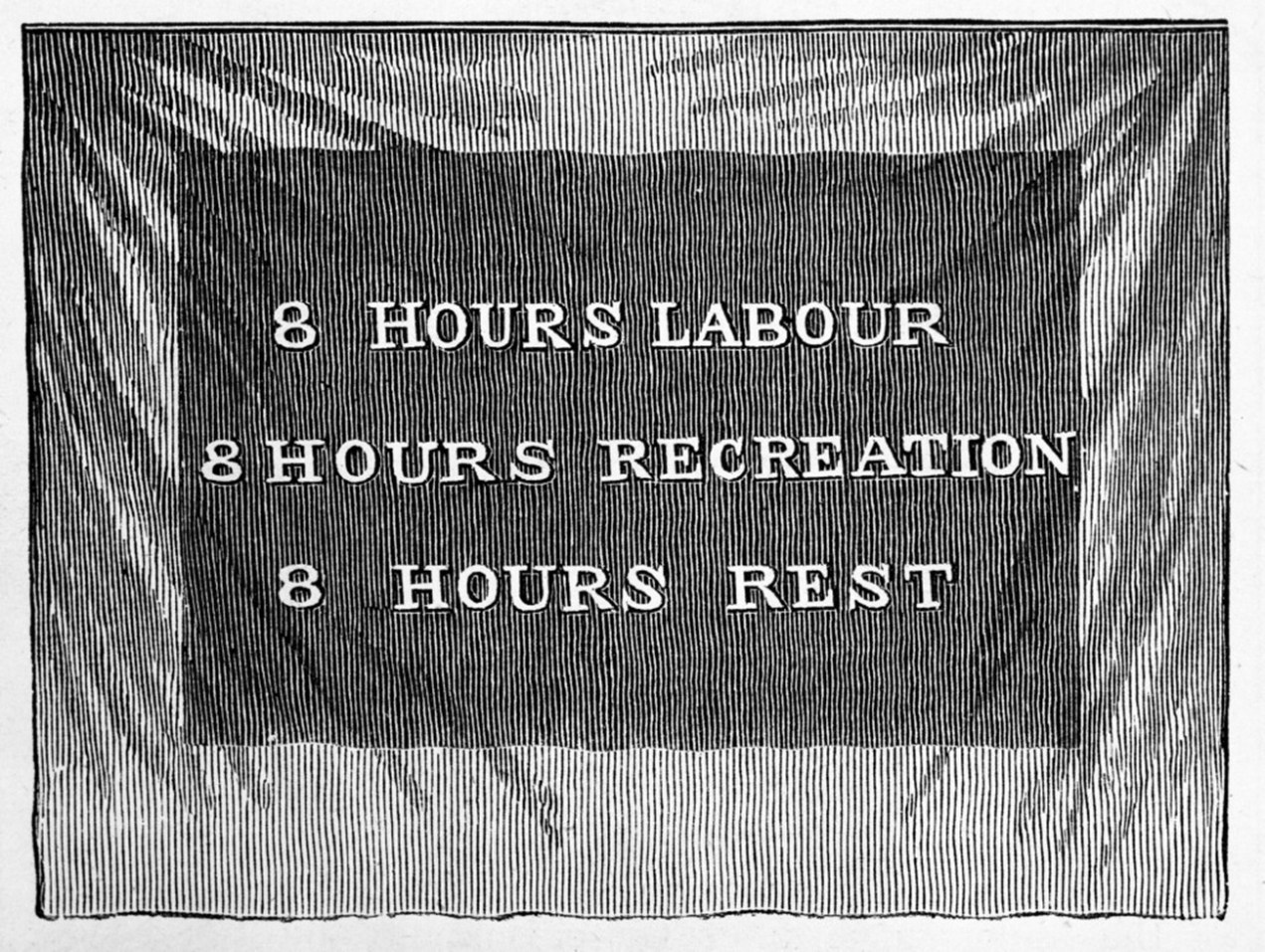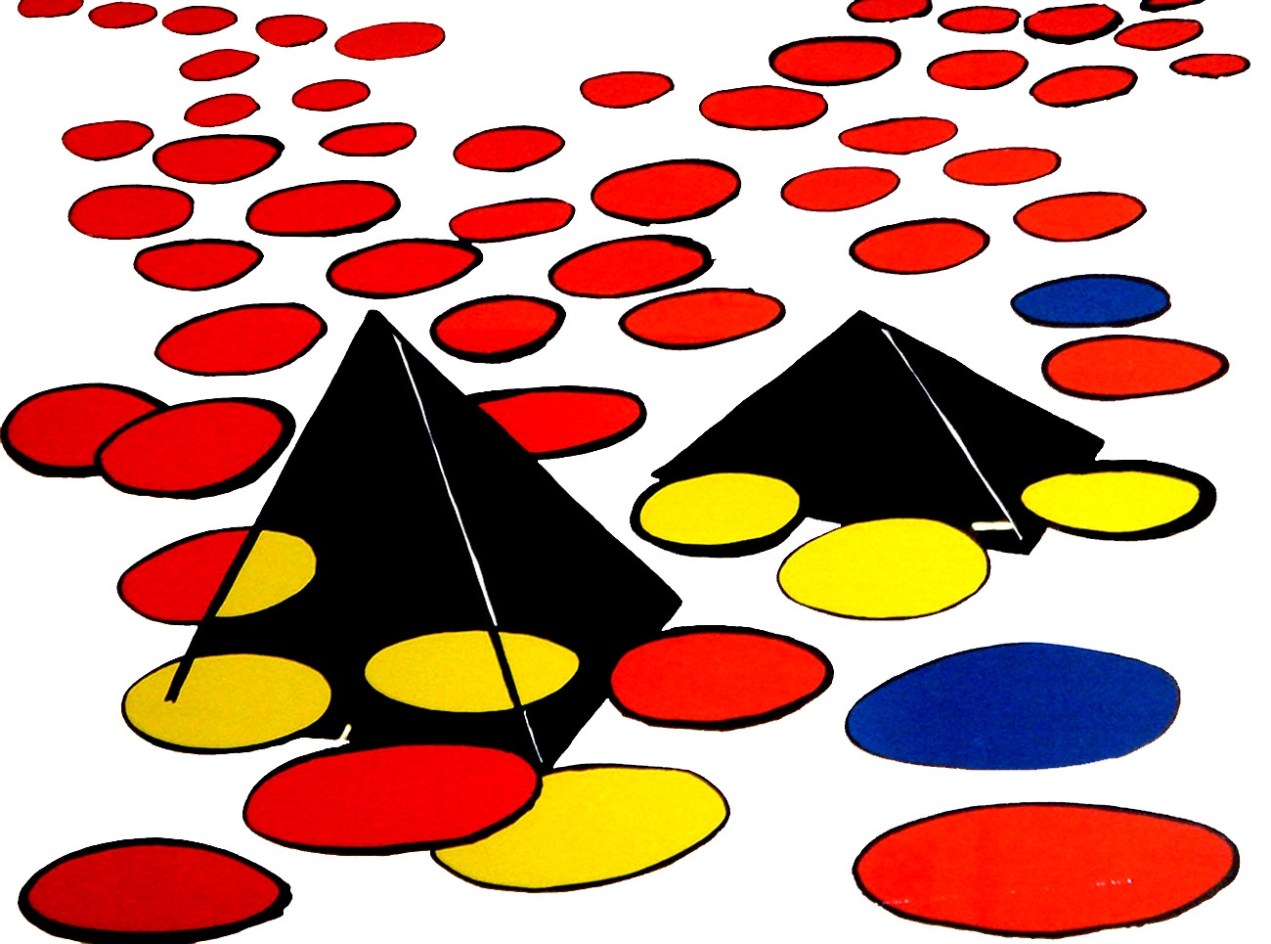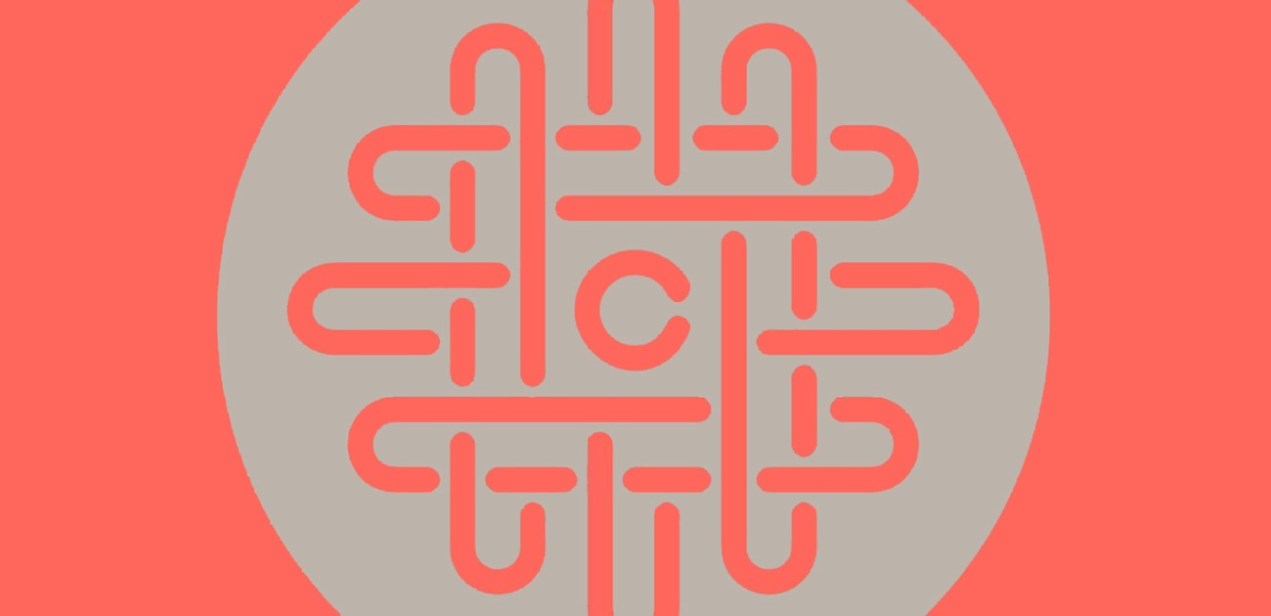The Wolf of Wall Street (2013) di Martin Scorsese e Il Capitale Umano (2014) di Paolo Virzì, benché accostabili in nome di una comune attenzione alla “finanzia creativa”, hanno a ben vedere poco da spartire. Al di là dell’essere ambientati in epoche differenti (per quanto il film di Scorsese giunga nelle sue immagini conclusive fino ai nostri giorni), quel che soprattutto distanzia i due racconti è il modo in cui i loro registi – e, si potrebbe dire, la cultura che rappresentano – mettono in scena storie di arricchimento basato su principi decisamente poco etici.
Scorsese guarda da vicino alla vicenda di Jordan Belfort (dal cui libro autobiografico il film è tratto) e partecipa alle sue scorribande con uno spirito di divertita indulgenza. Il messaggio che traspare – peraltro esplicitato da alcune battute chiave del film – è che nella situazione vissuta da Belfort fosse davvero difficile comportarsi altrimenti. Del resto Belfort ha pagato il suo debito con la giustizia e si è in seguito reinventato, a chiudere il cerchio della redenzione e del valore simbolico della sua parabola, come “motivational speaker”.
autobiografico il film è tratto) e partecipa alle sue scorribande con uno spirito di divertita indulgenza. Il messaggio che traspare – peraltro esplicitato da alcune battute chiave del film – è che nella situazione vissuta da Belfort fosse davvero difficile comportarsi altrimenti. Del resto Belfort ha pagato il suo debito con la giustizia e si è in seguito reinventato, a chiudere il cerchio della redenzione e del valore simbolico della sua parabola, come “motivational speaker”.
Da parte sua, Virzì non ha l’opportunità di guardare con distacco a una vicenda reale, ma trae spunto da un testo di fiction (il film è basato sull’omonimo romanzo dell’americano Stephen Amidon) per calarlo nella contemporaneità italiana. Quest’ultima è troppo vicina per essere guardata con un’ironia che non sia tragicomica – da qui l’evidente parentela del film con la classica commedia all’italiana degli anni ’60-70 – e come conseguenza l’atteggiamento del regista è, come simboleggiato dalle frequenti inquadrature in campo largo, di critica distanza dai suoi personaggi.
dell’americano Stephen Amidon) per calarlo nella contemporaneità italiana. Quest’ultima è troppo vicina per essere guardata con un’ironia che non sia tragicomica – da qui l’evidente parentela del film con la classica commedia all’italiana degli anni ’60-70 – e come conseguenza l’atteggiamento del regista è, come simboleggiato dalle frequenti inquadrature in campo largo, di critica distanza dai suoi personaggi.
In definitiva, laddove Scorsese esorcizza i misfatti del “lupo” di Wall Street usando l’ironia e presupponendo la redenzione (ponendosi all’interno della filmografia americana come contraltare al dittico su Wall Street di Oliver Stone), Virzì descrive con preoccupato e impotente sdegno una vicenda che è ancora da metabolizzare. Lo scambio di battute simbolo del film, quello ripetuto in questi giorni in ogni articolo a riguardo, è in questo senso piuttosto chiaro:
«- Avete scommesso sulla rovina del nostro paese e avete vinto.
– ABBIAMO vinto: ci sei anche tu».
[ illustrazione: foto di scena da Il Capitale Umano di Paolo Virzì, 2014 ]
(2013) l’economista americano Tyler Cowen immagina una feroce polarizzazione della società, causata dall’influenza delle nuove tecnologie sulle attività lavorative. Il mondo verrà a trovarsi diviso, secondo Cowen, tra coloro il cui lavoro sarà reso obsoleto dalla tecnologia e chi invece riuscirà a sopravviverle. Ricollegandosi idealmente ad alcune delle tesi contenute in La fine del lavoro
di Jeremy Rifkin (1995), Cowen immagina una middle class largamente composta da “bohémien” che saranno sempre meglio istruiti, soprattutto grazie a risorse on-line gratuite, ma si accontenteranno di salari medio-bassi.