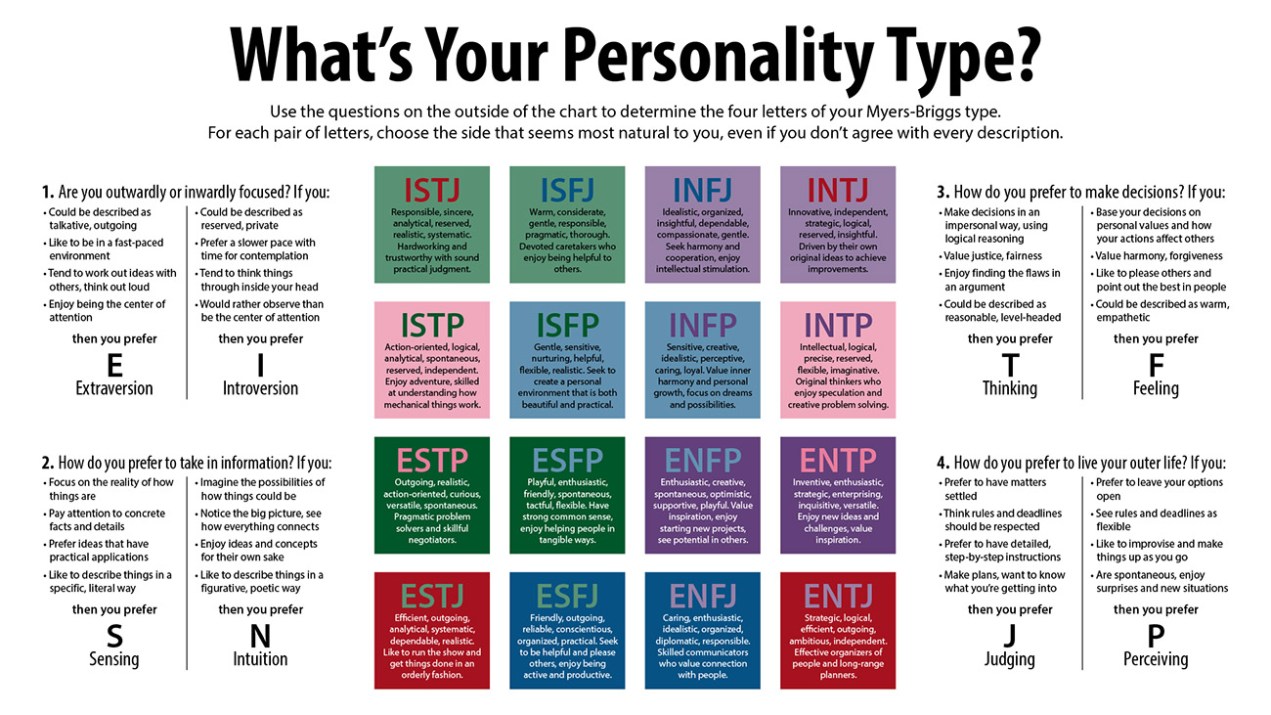Sebbene il neo-luddismo vanti una solida tradizione di pensiero e azione, riconducibile – a seconda delle preferenze – tanto al Martin Heidegger di La questione della tecnica (1953) quanto a Unabomber, chi si azzarda oggi a criticare l’influenza di web, computer e smartphone raramente è preso sul serio. Viene anzi zittito da un coro inneggiante alle “magnifiche sorti e progressive” offerte dalla più recente tecnologia. Si è dunque colti da una certa curiosità nel leggere l’articolo pubblicato da Clay Shirky su «Medium», dove lo studioso americano – noto come autore di Surplus cognitivo (2010), testo che ha contribuito a legittimare internet come amplificatore di apprendimento – si scaglia contro l’invasività dei device digitali. Se anche i cyber-ottimisti iniziano a simpatizzare per il neo-luddismo, qualcosa sta forse cambiando.
Come docente universitario, Shirky afferma di aver registrato nel corso degli anni un fenomeno ormai comune a qualsiasi livello scolastico e in ambito di formazione degli adulti: il tasso di disattenzione è direttamente proporzionale alla presenza in classe di device digitali. La soluzione di Shirky? Un inaspettato diktat, peculiare soprattutto per chi come lui insegni teoria e pratica dei nuovi media: computer e smartphone rigorosamente spenti. Al suono di “lids down”, attenzione, vivacità, partecipazione e discussione hanno magicamente fatto ritorno in aula.
A essere qui chiamato in causa non è soltanto il multitasking, con le sue ormai note conseguenze nefaste. C’è in gioco altro, espresso da Shirky tramite due metafore. La prima è quella del fumo passivo: un computer aperto o uno smartphone luminoso agiscono come disturbatori anche nei confronti di chi viene a essi esposto indirettamente, generando una propagazione virale – e autolegittimante – della disattenzione. La seconda metafora è quella della concorrenza: in un’aula infestata da apparecchi elettronici, chi lavora sull’apprendimento dei suoi interlocutori si trova a dover fronteggiare l’assalto di hardware e software che sembrano pensati appositamente per costituire una coesa armata della disattenzione.
Con riferimento a un’immagine popolarizzata dallo psicologo Jonathan Haidt nel libro Felicità: un’ipotesi (2008), Shirky rivolge un monito a chiunque si occupi di apprendimento. Quando siamo in aula spesso pensiamo di poterci rivolgere unicamente alla razionalità dei nostri interlocutori, resa in metafora da Haidt come una guida o un conducente (rider). In realtà, il conducente controlla le redini di un animale piuttosto corpulento e lento: un elefante, cioè la parte emotiva del cervello. Senza una paritaria attenzione per queste due componenti, risulta difficile che qualcuno sia davvero coinvolto in un processo di apprendimento. Se le app hanno imparato molto velocemente a rivolgersi all’elefante, l’educazione e l’apprendimento di giovani e adulti non possono continuare a parlare solo alla guida.
[ illustrazione: immagine tratta dal film Computer Chess (2013) di Andrew Bujalski ]