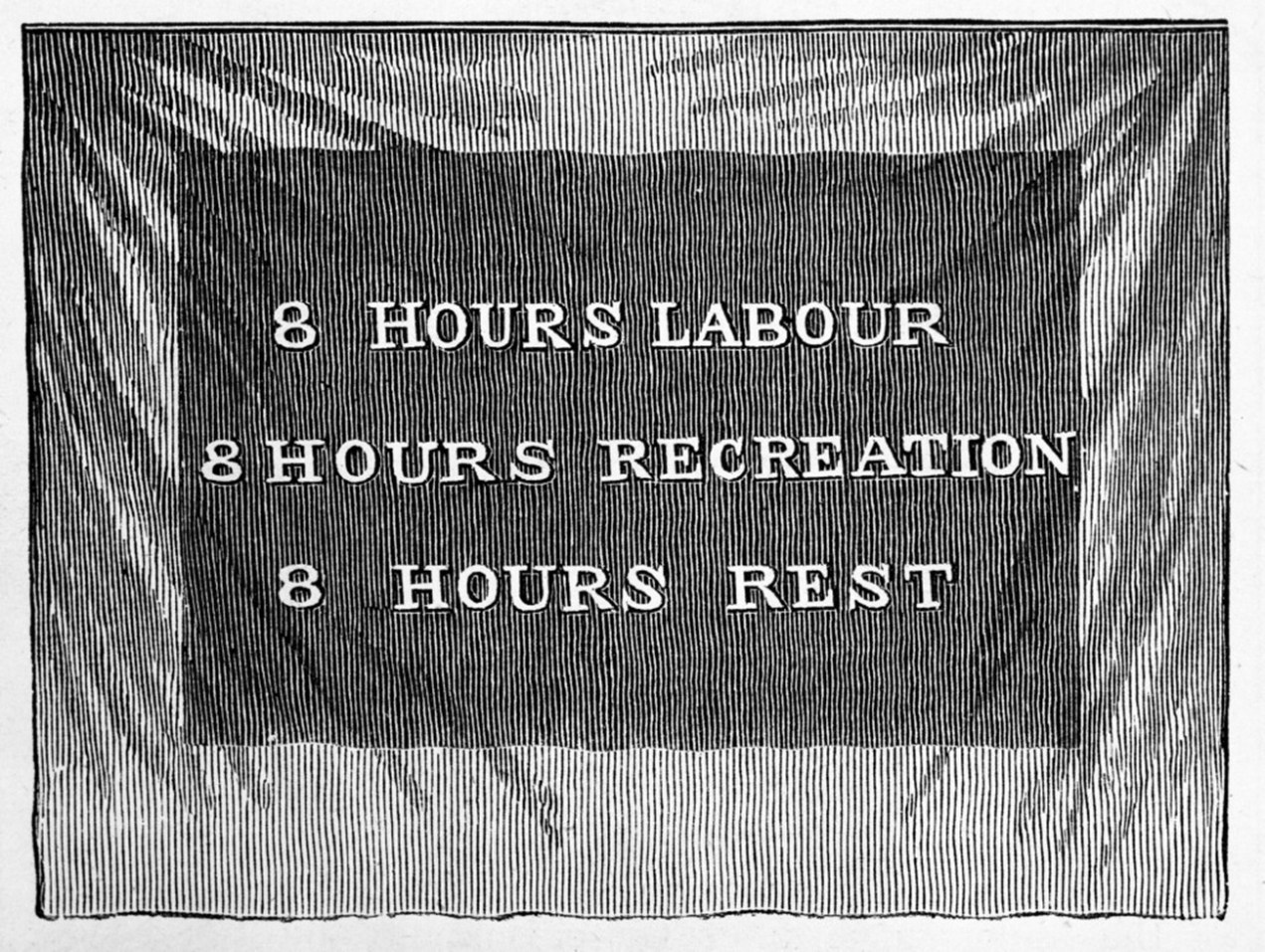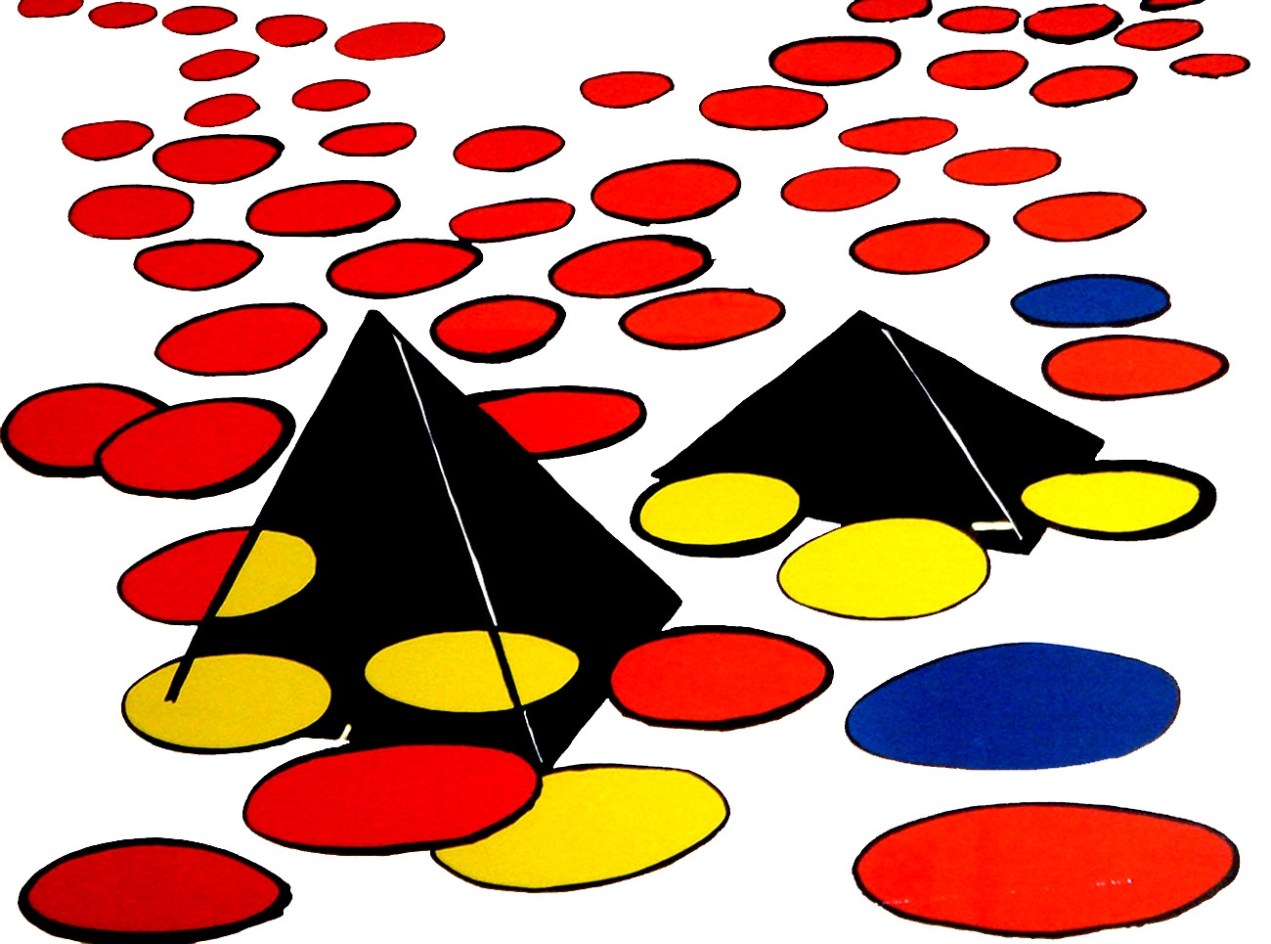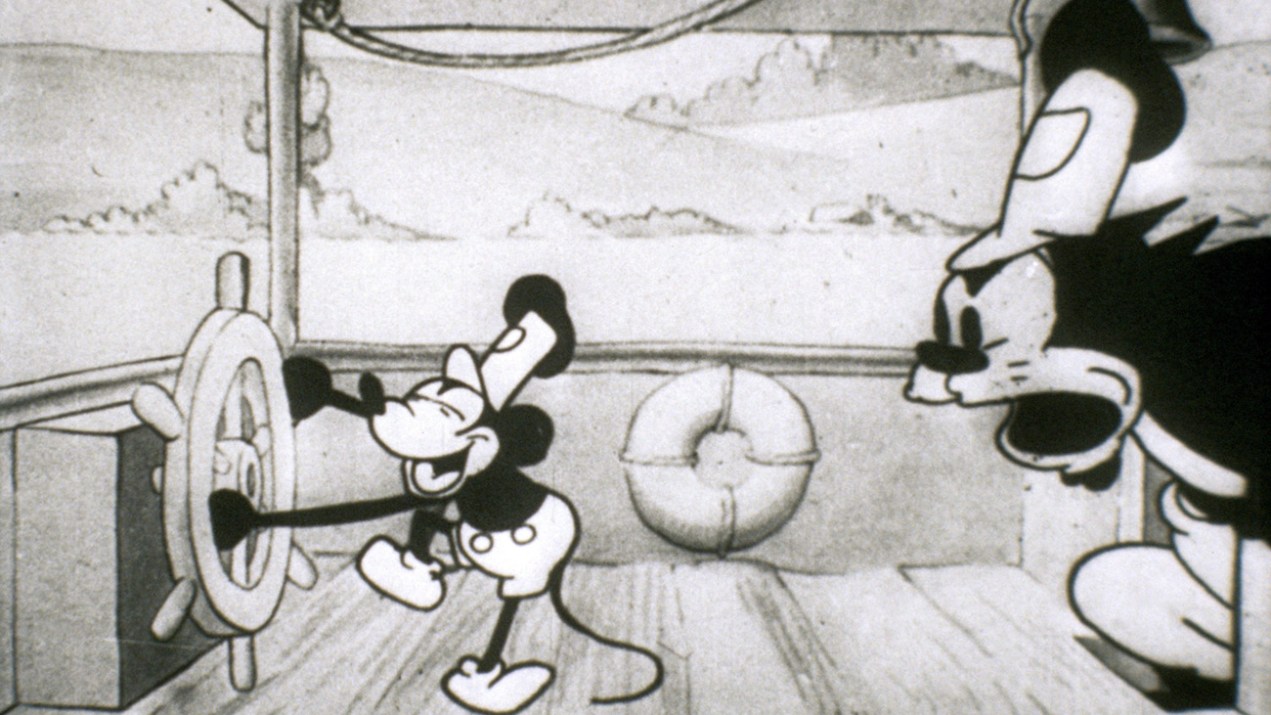“Creatività” è categoria aziendale per eccellenza, come ben dimostrato dal fatto che su Linkedin essa risulta la “buzzword” più in voga nei résumé di migliaia di persone. Sono state le aziende ad appropriarsi – ormai molti anni fa – di questo concetto e sono proprio le aziende a continuare a richiedere formazione orientata alla creatività, alimentando un mercato le cui principali beneficiarie sono state fino a oggi le società di consulenza. Ma le cose stanno cambiando, forse proprio in relazione ai résumé sopra citati.
In America i corsi universitari sulla creatività stanno spuntando come funghi. Dalla State University of New York alla Saybrook di San Francisco; dalla St. Andrews di Laurinburg alla Drexel di Philadelphia: questi i nomi delle prime istituzioni statunitensi che hanno attivato master o dottorati dedicati al tema. Di certo non tarderanno ad aggiungersene altre e c’è da immaginare che la moda possa in breve diffondersi anche in Europa.
È difficile valutare le conseguenze di questa novità. Dal punto di vista accademico, essa farà certo gola a molte università, pronte a far cassa grazie a nuovi corsi molto “vendibili” (un po’ come successo nei primi anni 2000 con la moda dei corsi interfacoltà dedicati al management della cultura). D’altro canto, provocherà reazioni contrariate da parte dei docenti meno inclini a fare i conti con una categoria davvero un po’ troppo aziendale. Per quanto riguarda l’aspetto divulgativo del concetto, si può forse sperare che veicolare l’idea secondo cui la creatività “si insegna” (e dunque si impara) contribuisca a indebolire l’alone esoterico che da sempre la accompagna, ma questo sarà da valutare nel corso del tempo.
Certo è che trent’anni circa di ossessione aziendale per la creatività hanno reso questo concetto materia da curriculum vitae al pari dei cliché sul “lavoro di gruppo / orientamento ai risultati”. Il fatto che uno studente sia oggi disposto a investire sulla promessa dell’acquisizione di una competenza che risponde al nome di creatività è probabilmente frutto di questa efficace opera di propaganda.
[ illustrazione: particolare dalla locandina del film Altered States di Ken Russell, 1980 ]