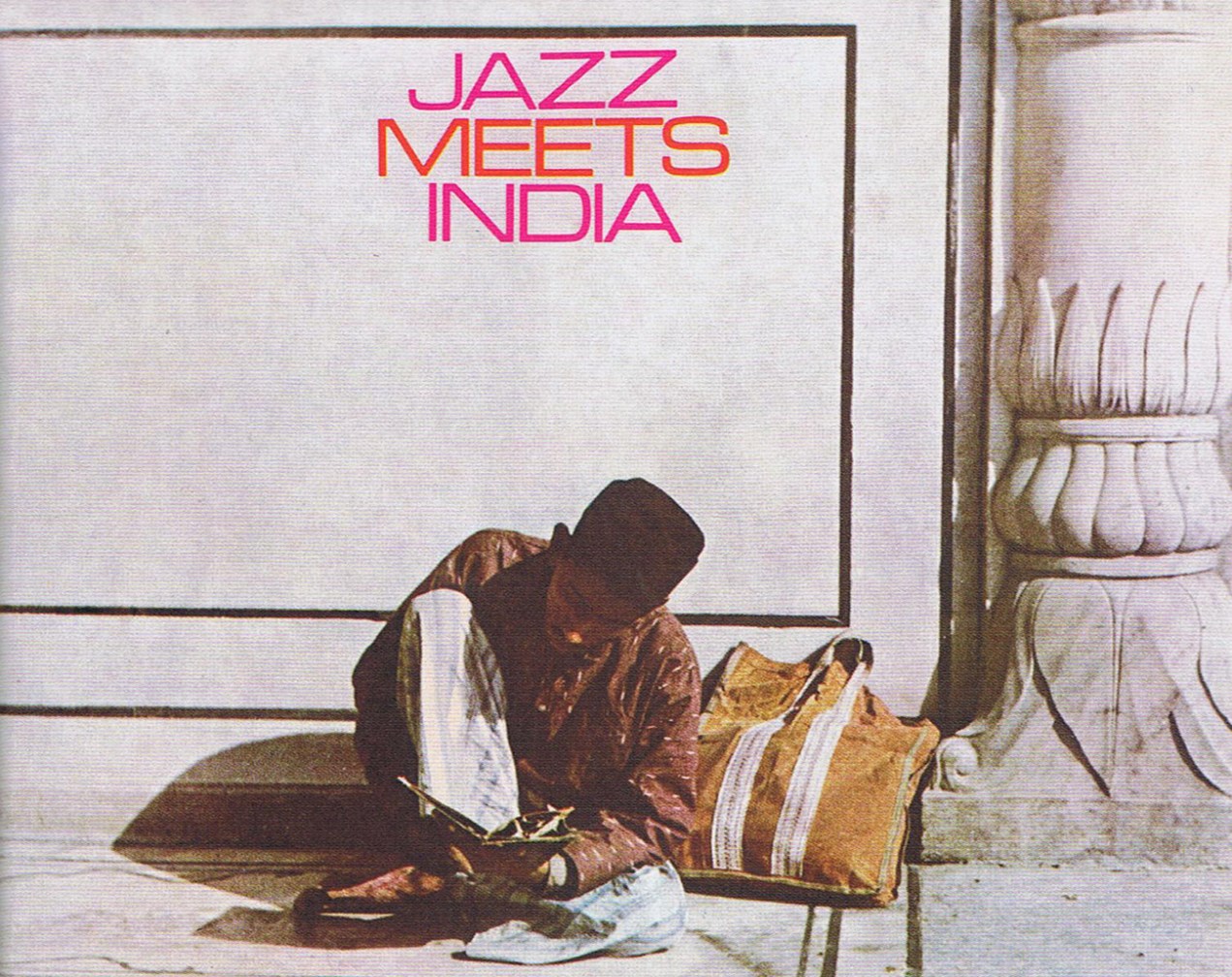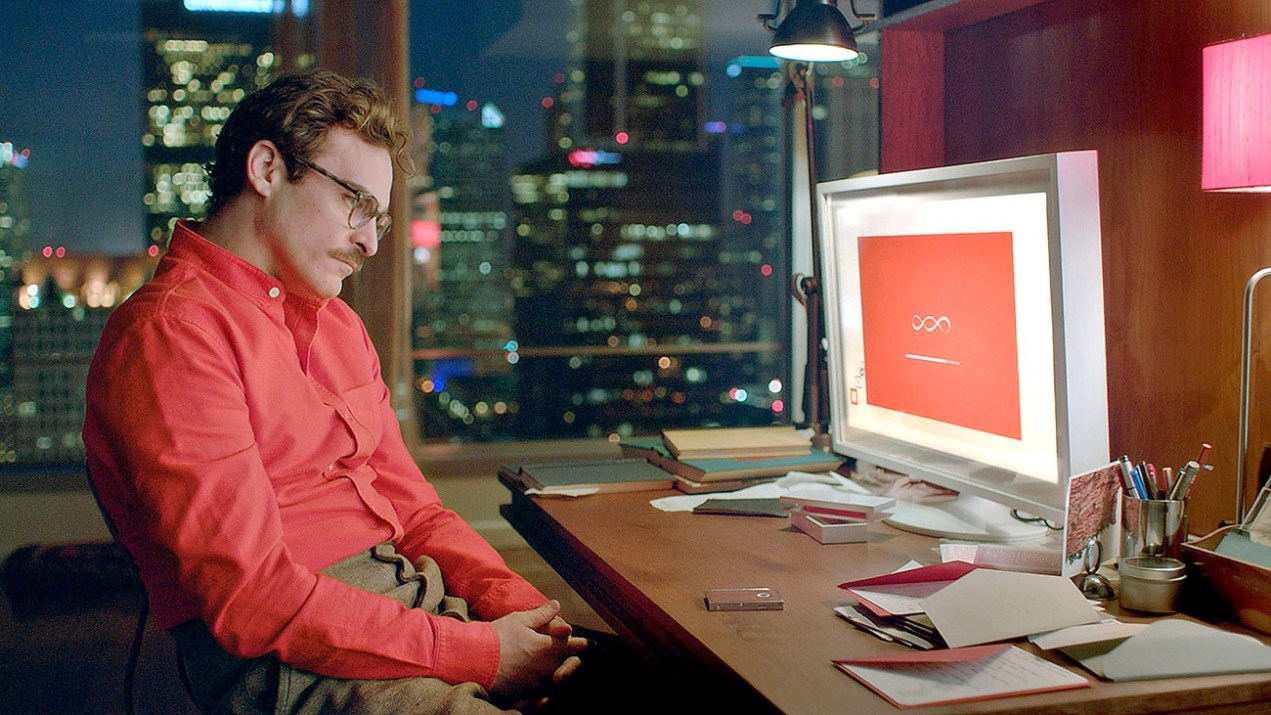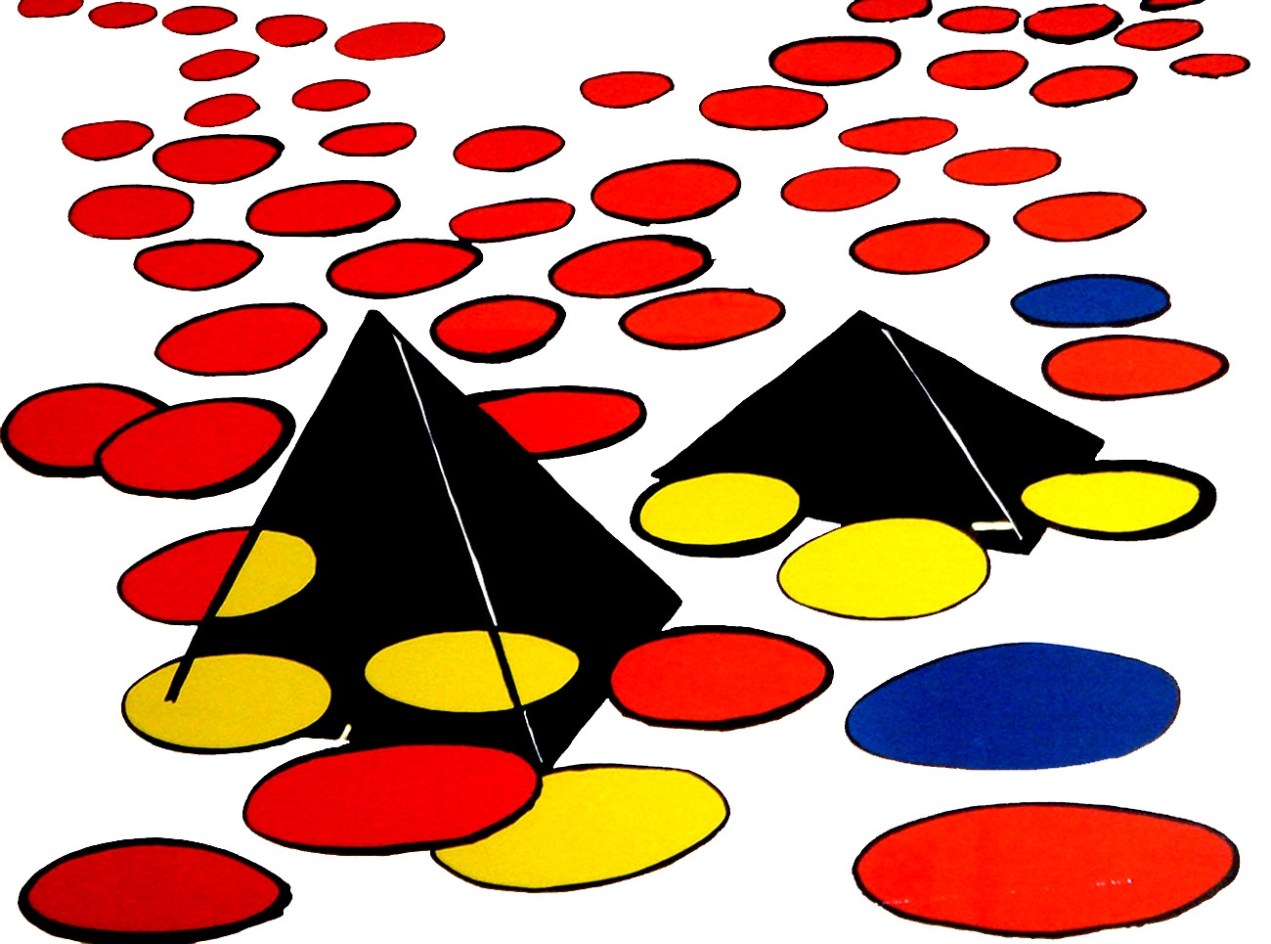Fa il suo arrivo nelle librerie italiane Jugaad innovation di Navi Radjou, Jaideep Prabhu e Simone Ahuja. L’editore Rubbettino – con la curatela di Gianni Lo Storto e Leonardo Previ – porta finalmente in Italia il libro che ha reso famoso in tutto il mondo un approccio al 100% indiano che ha molto da insegnare a quanti si sentono oggi chiamati, tanto nelle aziende quanto nella quotidianità, a fare di più con meno.
“Jugaad”, termine Hindi pressoché intraducibile in maniera letterale, è un sinonimo di creatività, quella vera. Vale a dire: niente di geniale o magico, ma grande abilità nel trovare nuove soluzioni per vecchi problemi, usando al meglio le risorse di contesto. Del resto, come affermava il matematico Henri Poincaré (1854-1912):
«Essere creativi significa esercitare la capacità di combinare elementi esistenti in modo nuovo e utile».
Questo è il nucleo centrale dell’approccio jugaad: un grande patrimonio di esempi frugali provenienti da una nazione che ha saputo fare di più con meno per risolvere problemi quotidiani e per produrre un nuovo modello di innovazione per il mondo delle imprese. Ed è proprio in tema di innovazione che l’approccio jugaad ha più da offrire:
«Per troppo tempo il modello di innovazione occidentale è stato simile a un’orchestra: top-down, rigido e guidato dagli alti livelli organizzativi. Questo tipo di modello funziona bene in un mondo stabile e ricco di risorse. Ma poiché quello che le aziende occidentali dovranno affrontare nei prossimi anni è un contesto business complesso e imprevedibile, esse hanno bisogno di un approccio alternativo, più simile a quello di un gruppo jazz: bottom-up, capace di improvvisare, fluido, collaborativo e inserito in una cornice di profonda conoscenza. L’approccio jugaad rappresenta quest’alternativa».
Questo passaggio di Jugaad Innovation rende particolarmente evidente che in un momento di crisi economica globale è diventato necessario, anche per le aziende occidentali, assumere un diverso paradigma di innovazione, non più basato su un’aspettativa di abbondanza ma sulla capacità di muoversi al meglio nella scarsità e nell’imprevedibile. Gli autori del testo esemplificano questa idea facendo uso della più potente metafora di innovazione e collaborazione emergente che le imprese hanno a disposizione: quella del jazz.
L’organizzazione come orchestra, metafora ancora oggi piuttosto popolare in molte aule di formazione, ha fatto il suo tempo. Per innovare – e ancor prima sopravvivere – in un contesto di scarsità c’è oggi bisogno di coltivare le competenze tipiche di un jazzista: ascolto, interplay, improvvisazione. Solo volgendosi in questo modo al contesto è possibile fare di più con meno. Ecco cos’ha da insegnarci, arricchendo questo messaggio della saggezza e dell’esperienza indiana, l’approccio jugaad.
[ illustrazione: particolare dalla copertina del disco Jazz Meets India di Irene Schweizer Trio & Dewan Motihar Trio, 1967 ]