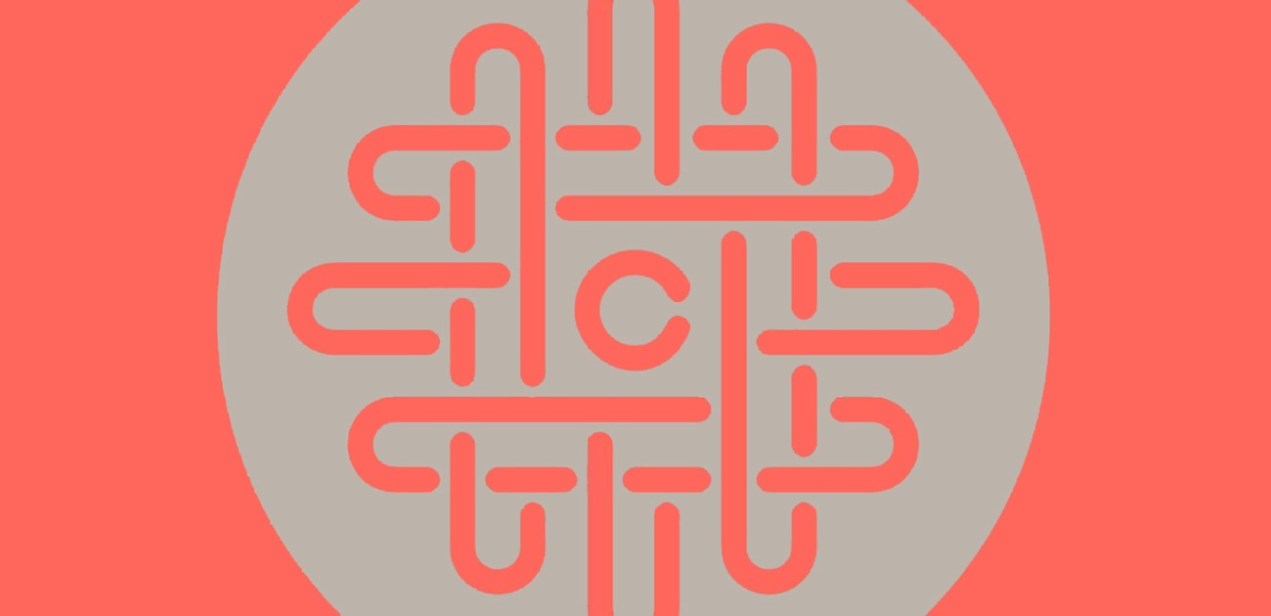Nel saggio del 1995 Che cos’è un intellettuale?, Tomás Maldonado si cimenta con l’analisi critica di una delle categorie più problematiche – e nonostante tutto cruciali – dell’epoca moderna e contemporanea.
Dopo aver individuato l’origine del concetto di intellettuale (e soprattutto del discorso a suo riguardo) nella Francia di fine Ottocento – e nello specifico in coincidenza con l’affare Dreyfus e il J’accuse di Félix Faure – Maldonado si cimenta tanto col cercarne antecedenti nell’antichità quanto nel leggerne gli sviluppi che conducono all’epoca contemporanea. Centrale rispetto alla “crisi” del ruolo dell’intellettuale sviluppatasi nel corso del ‘900 è la sua sovrapposizione con la figura dell’esperto o, se si preferisce, dello specialista di una disciplina scientifica o umanistica. Come Maldonado mostra in maniera eloquente, la svolta specialistica ha rappresentato un’interpretazione deteriore e riduttiva della figura originaria dell’intellettuale:
«Di norma, quello che noi chiamiamo ora intellettuale era un uomo che esercitava molti mestieri e che, pertanto, era impegnato personalmente nei più svariati ambiti dell’agire sociale. Nella stragrande maggioranza, gli intellettuali del passato sono stati, per così dire, uomini multiuso. Non assolvevano nella società un unico ruolo, ma molteplici. La ragione è ovvia. A pochi privilegiati era consentito “vivere del proprio mestiere”».
Un ulteriore tema critico riguarda il ruolo “oracolare”, cioè di influenza sull’opinione pubblica, che la figura dell’intellettuale ha perso nel corso del tempo. Questo, secondo l’autore, sarebbe accaduto soprattutto a causa dei media, che fungono da oracoli del nostro tempo. Maldonado scrive nel 1995, anni in cui era fra i primi in Italia a occuparsi di internet e di “reale e virtuale”. Difficile dunque non pensare al ruolo che la crescita di internet ha in seguito avuto nel propiziare una “parcellizzazione oracolare” che si estende oggi fino ai post e ai commenti dei social network, rendendo ancora più difficile la legittimazione di un’opinione forte e dunque il netto riconoscimento di figure intellettuali.
[ illustrazione: Francis Bacon, Study for Self-Portrait – 1985 ]