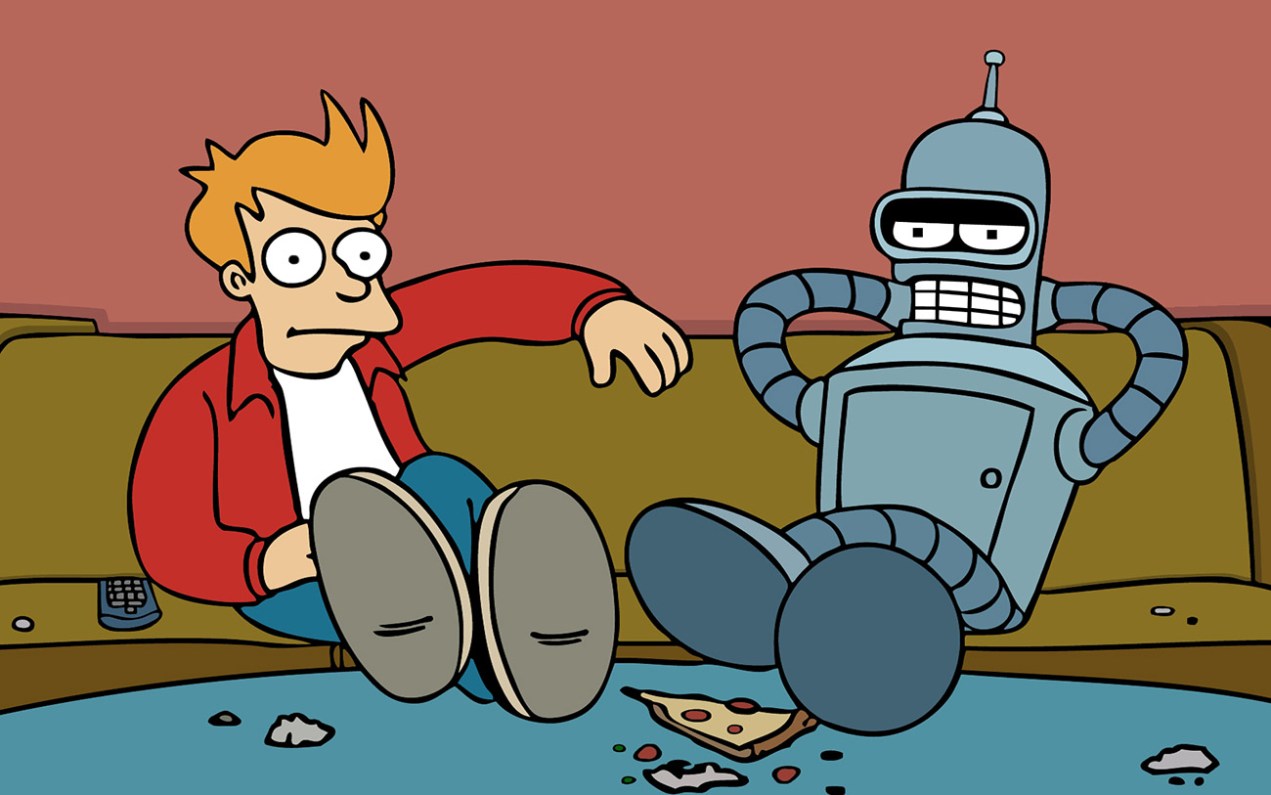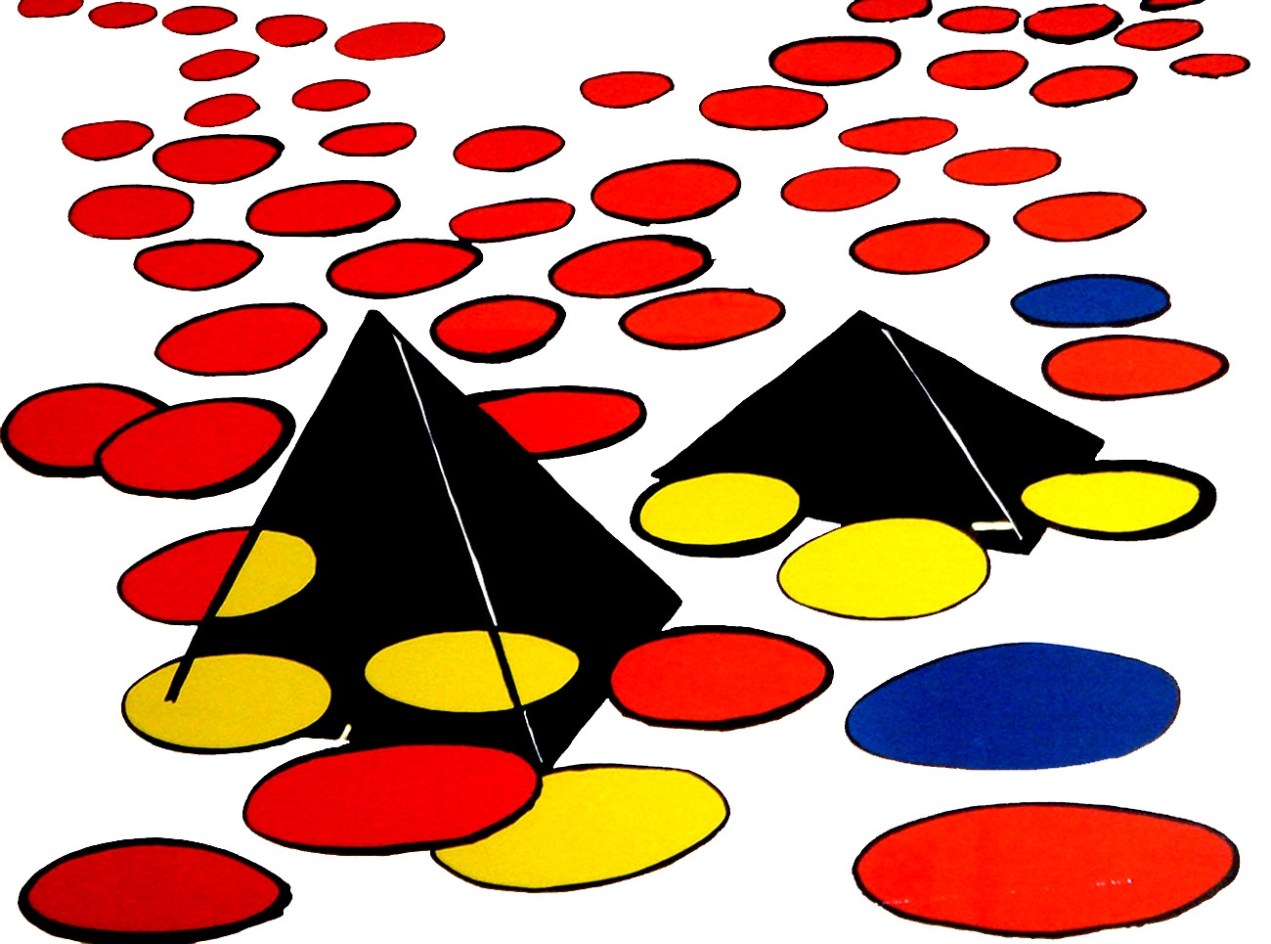«Non siamo in America, dove non c’è cultura umanistica che affonda nel passato, e dove il paesaggio e la realtà giornaliera coincidono perfettamente con la cultura americana».
«Essendo il nostro paese molto vecchio permangono in molti suoi abitanti e nonostante il velocissimo processo di integrazione in corso che rende uguale ogni apparenza, alcuni frammenti di “cultura umanistica”: cioè autoctona, locale […]. Essi sono scomparsi completamente nella nuova borghesia imprenditoriale, piccola e grande, specialmente al Nord […], malata di una malattia americana: il pragmatismo».
Così scriveva Goffredo Parise (1929-1986) tra il luglio e l’agosto del 1974, in due articoli pubblicati su una rubrica di corrispondenza con i lettori da lui curata per il «Corriere della Sera» in quegli anni (di cui oggi viene presentata una piccola selezione in Dobbiamo disobbedire, 2013). Qui il tema è quello delle origini culturali e della loro cancellazione da parte del pensiero funzionalista diffuso dalla cultura lavorativa di stampo americano. Dalle parole di Parise emerge il riconoscimento di una cultura “umanistica”, retaggio di un passato agricolo, popolare paesano e cattolico, e insieme la consapevolezza di non poter fare nulla di fronte alla sua scomparsa, causata da quella che, in altri articoli tratti dalla sua rubrica, egli chiama con ineluttabile semplicità la “forza delle cose”.
Il frammento tratto da Parise ne evoca un altro di Luciano Bianciardi (1922-1971), estratto da Il lavoro culturale (1957-1964):
«Kansas City, Kansas City è la nostra realtà, altro che storie! Le origini della città? L’anno di fondazione? Ma era il 1944, né più né meno. Prima di allora non esisteva, era stata fondata dagli americani, che, giungendo fra noi, avevano spianato un campo per farvi atterrare gli aerei, aperto rivendite di coca-cola, spacci di generi alimentari, dancings, depositi di materiale, creando all’improvviso un centro di traffici nuovi».
Kansas City è per Bianciardi la sua Grosseto, percepita dai più giovani – di cui lo scrittore si sente parte – come senza origini, nonostante ci fossero ancora molti accapigliati a cercarle, per esempio indagando la storia degli Etruschi. Per Bianciardi il dialogo è fra Grosseto/Kansas City e Milano, città che rappresenta “il lavoro culturale” e in cui si trova incarnata, tanto nella sostanza quanto nella forma del “linguaggio aziendale”, l’ideologia pragmatista di stampo americano di cui parlerà poi anche Parise. Non a caso, Bianciardi si trasferirà proprio a Milano in cerca di lavoro e riconsidererà con amarezza la sua Kansas City.
Questi due frammenti, scritti in anni diversi da autori coevi, fotografano lo sforzo dell’intellettuale nel dar conto di un momento che, per il nostro Paese, è stato di effettiva svolta e di forzato scontro culturale. Le parole di Bianciardi e Parise testimoniano un cambiamento il cui destino è forse solo oggi possibile vedere nel pieno sviluppo delle sue conseguenze.
[ illustrazione: articolo di «Epoca» del 29 aprile 1962 ]