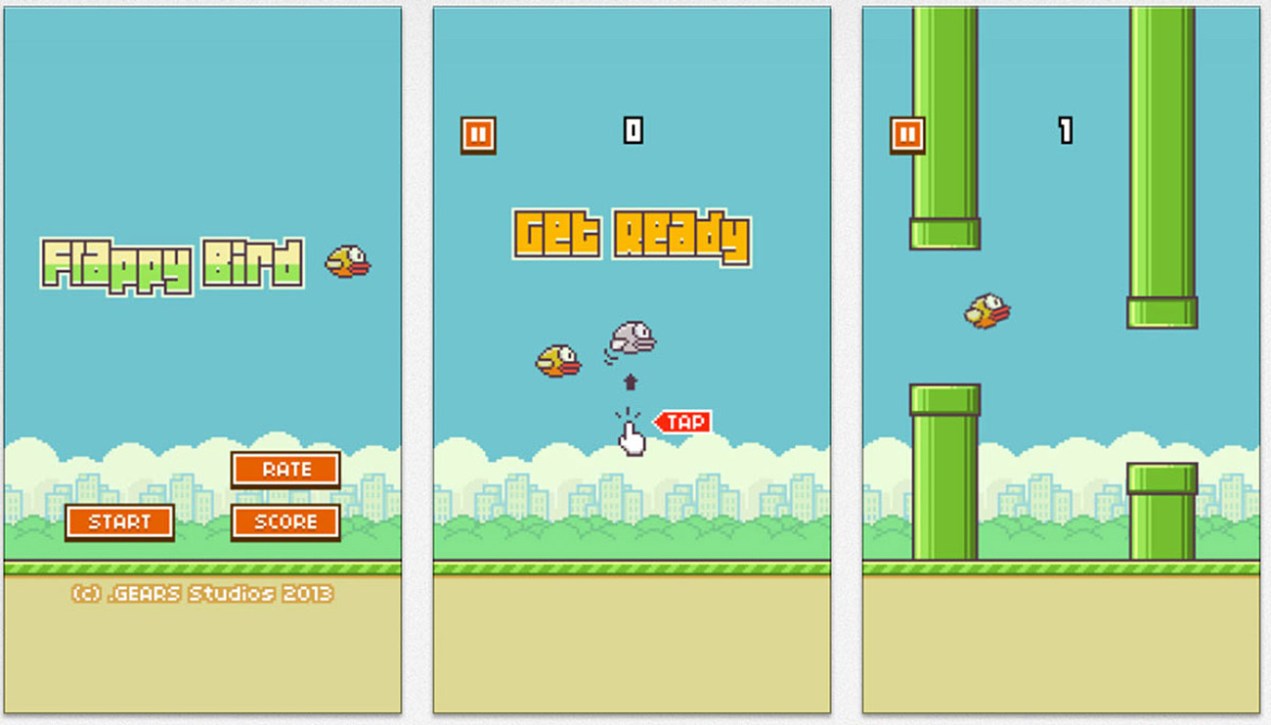Nel capitolo ambientato a Roma del libro-intervista con Peter Bogdanovich, Orson Welles racconta del suo antico desiderio di trasformare in film Cuore di tenebra
(1902) di Joseph Conrad, testo con il quale aveva già ottenuto un grande successo radiofonico. Era il 1939 e tutto fallì, come spesso accadeva a Welles, in mancanza di un budget adeguato. L’amarezza per un progetto mancato è aggravata dal fatto che esisteva già una sceneggiatura completa.
A Welles non andava di interpretare il temibile Kurtz (sarebbe stata una scelta troppo scontata), ma piuttosto il capitano Marlow. Attraverso i suoi occhi, grazie a una ripresa in soggettiva, avremmo vissuto l’intera vicenda. Poiché la maggior parte della narrazione vede il protagonista al comando della sua imbarcazione, Welles avrebbe potuto riprendere il suo volto riflesso nel vetro della cabina di pilotaggio, lasciandovi scorrere sotto il fitto paesaggio della foresta.
Se alla RKO l’idea di Welles fosse andata a genio, la soggettiva avrebbe debuttato al cinema con otto anni di anticipo su The lady in the lake, film del 1947 di Robert Montgomery. Quest’ultimo ha il principale merito di essere stato il primo a dimostrare che la soggettiva cinematografica rischia di fallire, quando protratta per un intero film (L’arca russa di Alexandr Sokurov è forse un’eccezione che conferma la regola). Nata per restituire l’autenticità e l’immediatezza dell’esperienza visiva, la soggettiva cinematografica finisce paradossalmente per risultare un espediente del tutto artificioso: vediamo sì con gli occhi del protagonista, ma non possiamo girare la testa dove vogliamo. Ma come sarebbero andate le cose, se fosse stato Orson Welles il primo a portarla al cinema?
[ illustrazione: Orson Welles in Citizen Kane, 1941 ]