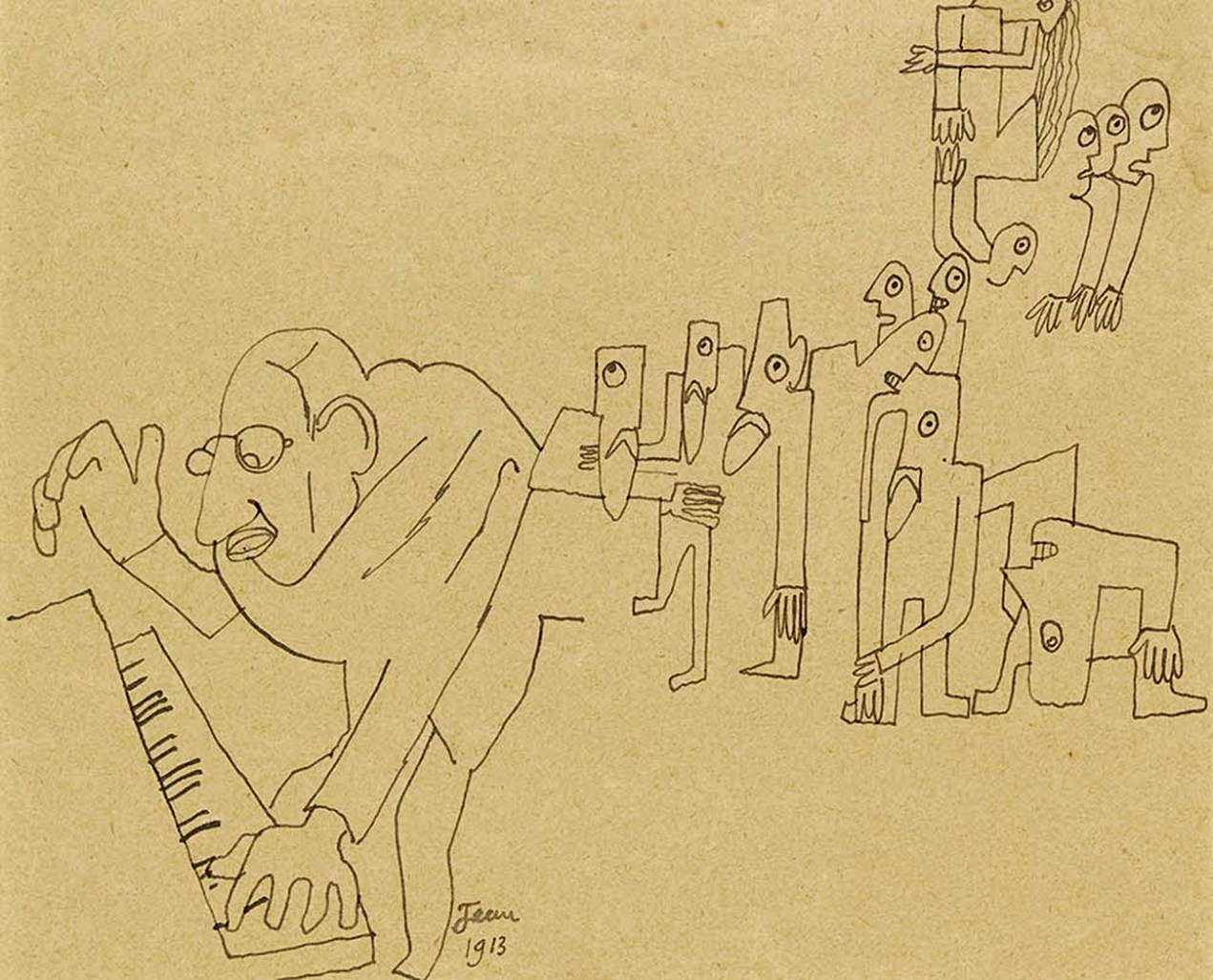Fred Herzog, classe 1930, è uno dei pionieri dell’uso del colore nella street photography. Prima di lui, per appena una manciata d’anni, solo Saul Leiter (1923-2013): se quest’ultimo iniziò a scattare a colori nel 1948, Herzog lo fece dal 1953, quando si trasferì dalla Germania al Canada. Alla fine degli anni ’40 il bianco e nero era considerato l’unico strumento “serio” di cui un fotografo di strada potesse avvalersi, il che rende rivoluzionario il lavoro di questi autori.
La peculiarità dell’opera fotografica di Herzog si lega anche allo strumento da lui scelto per registrare il colore del Canada (in particolare Vancouver), cioè la pellicola per diapositive Kodachrome ISO10. La sigla ISO10 rappresenta una sensibilità particolarmente restrittiva in termini di luce richiesta per impressionare la pellicola. Per comprenderlo è sufficiente pensare che la maggior parte delle macchine digitali ha oggi una gamma ISO che parte da 100 o 200 per arrivare a valori di 6400 e oltre. Questo significa che con le fotocamere attuali è possibile scattare con tempi di posa relativamente rapidi e a mano libera anche di sera (o in ogni caso con poca luce ambientale). Per converso, chi come Herzog utilizzava la Kodachrome ISO10 aveva bisogno di molta, molta luce. In cambio, otteneva un’altissima qualità e una quasi totale assenza di “grana” dell’immagine.
Se Herzog scelse una pellicola per diapositive – e per di più di così difficile utilizzo – fu per un semplice motivo economico: non poteva permettersi i costi della realizzazione di stampe. In quanto diapositive, alle sue immagini fu negato l’accesso alle gallerie e conseguentemente la diffusione presso un vasto pubblico. Questa scelta inizialmente penalizzante si è tuttavia rivelata vincente sul lungo periodo: in anni recenti, sull’onda di una riscoperta dell’opera del fotografo, le sue immagini sono state scansionate e stampate grazie alle più recenti tecnologie. In questo processo la qualità e la “longevità” della pellicola Kodachrome (doti quasi uniche e per esempio del tutto opposte a quelle di pellicole come le Ektachrome) sono state fondamentali per donare una seconda giovinezza – e una meritata fama – al colore delle immagini di Herzog.
[ illustrazione: Fred Herzog, Man with bandage – 1968 ]