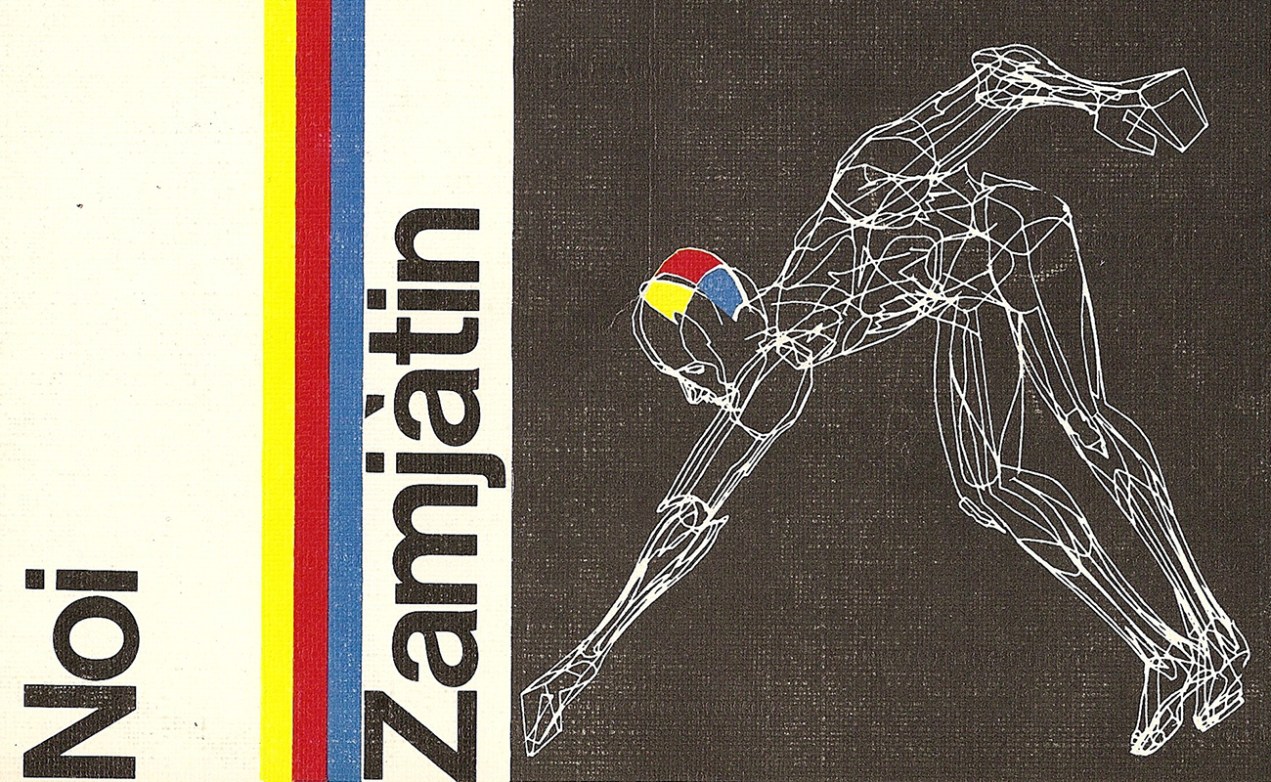Il sostantivo “Manhattanization” è difficilmente traducibile in italiano ma compare sul vocabolario anglo/americano come neologismo dal significato ben preciso: trasformare l’apparenza e il carattere di una città costruendovi un denso agglomerato di grattacieli. Questo significato – con evidente riferimento al ricco distretto newyorkese di Manhattan – ha preso piede negli anni ’60-70, periodo durante il quale la città di San Francisco è stata criticamente descritta come in preda a un aggressivo processo di urbanizzazione, detto anche “manhattanizzazione”.
Il termine è oggi usato – almeno secondo il «New Yorker» – con una nuova funzione, cioè quella di stigmatizzare la trasformazione di una città in mero “campo gioco” per le classi abbienti. Il riferimento è di nuovo Manhattan, ora intesa come esempio negativo di concentrazione del benessere urbano (circa il 39% della ricchezza cittadina coincide conl’1% dei residenti). Altre città americane, fra cui Boston e di nuovo San Francisco, stanno andando incontro a questo tipo di trasformazione sociale influenzata dalle élite lavorative.
Le disuguaglianze del territorio newyorkese sono state descritte anche dal concetto di “città duale” (dual city), elaborato dalla sociologa Saskia Sassen nei primi anni ’90 per mettere in luce come la polarizzazione relativa al reddito cittadino sia stata causata dall’allontanamento dalle attività manifatturiere e dalla correlata “scomparsa” della classe media. Interpretata in questo senso, la “manhattanizzazione” risulta un fenomeno di proporzioni globali.
[ illustrazione: foto di Manhattan realizzata da Jack Delano, 1941 ]