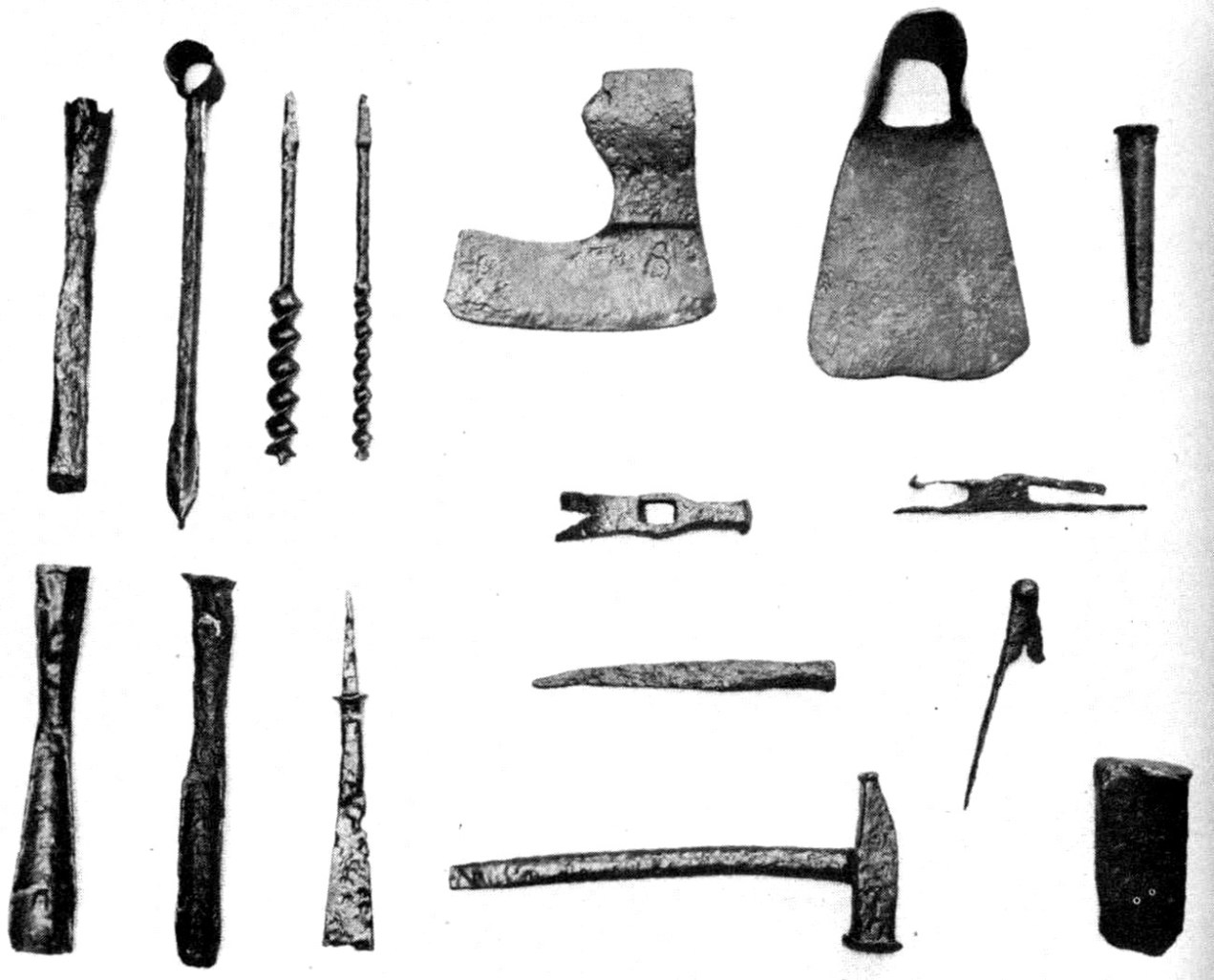Fra le varie ipotesi di reviviscenza del taylorismo emerse dal dibattito manageriale degli ultimi anni, ve ne è una dotata di particolare concretezza. Se è vero che alla base dello scientific management è, da sempre, il progressivo perfezionamento nella gestione di dati, il fenomeno tecno/sociale noto come “big data” sembra offrire la possibilità di una nuova, aggiornata incarnazione dello spirito tayloristico.
La reincarnazione è resa possibile dalla quasi perfetta comunanza di intenti tra un elemento tecnologico – l’enorme, pervasivo potere delle attuali infrastrutture tecnologiche – e un tratto culturale, cioè l’ideologia cyber-ottimista diffusa nel mondo dal modello delle startup americane. È la congiunzione fra questi due fattori – nota un recente articolo della rivista «Pop Matters» – a dar vita al taylorismo 2.0.
La rinascita di un’attitudine al continuo perfezionamento individuale, ben rappresentata sul web da «Life Hacker», dalla rubrica Work Smart di «Fast Company» e da molti articoli di Linkedin Pulse – testimonia della completa internalizzazione dei principi di controllo del taylorismo fatta propria da orde di “knowledge worker”. In altri termini, mettersi al servizio dell’efficientismo della macchina taylorista non è mai stato così cool.
Se questa indole rappresenta bene il colletto bianco medio, dalle organizzazioni d’impresa e dai dipartimenti HR sembra provenire una consonante risposta, riassunta dalle sperimentazioni in termini di raccolta e valutazione dati identificate dalla sigla “people analytics”. Misurare è tornato dunque decisamente di moda, con buona pace di vent’anni di letteratura manageriale spesi ad affiancare l’aggettivo “emotivo” al mondo del business.
[ illustrazione: fotogramma dal film Modern Times di Charles Chaplin, 1936 ]