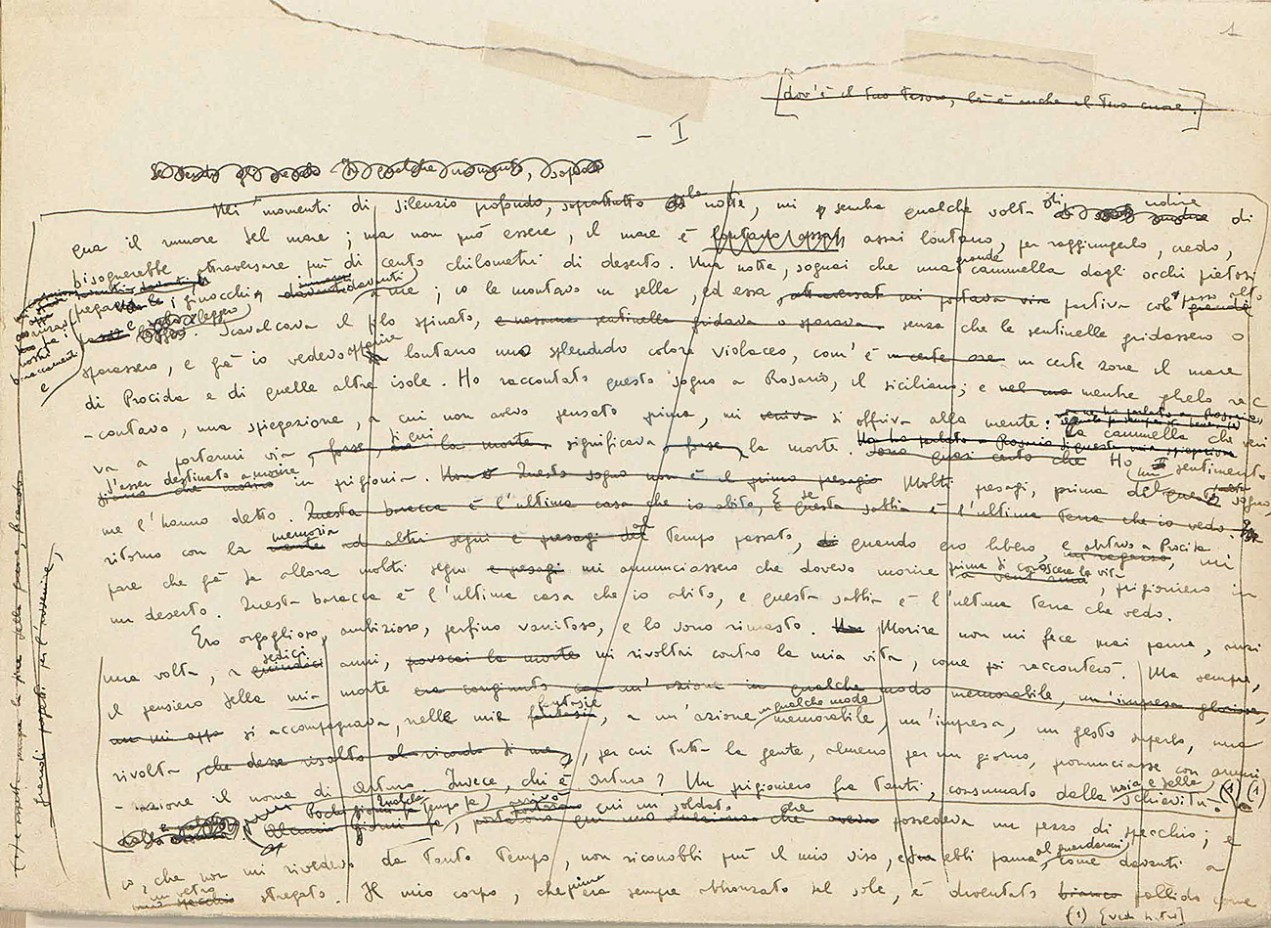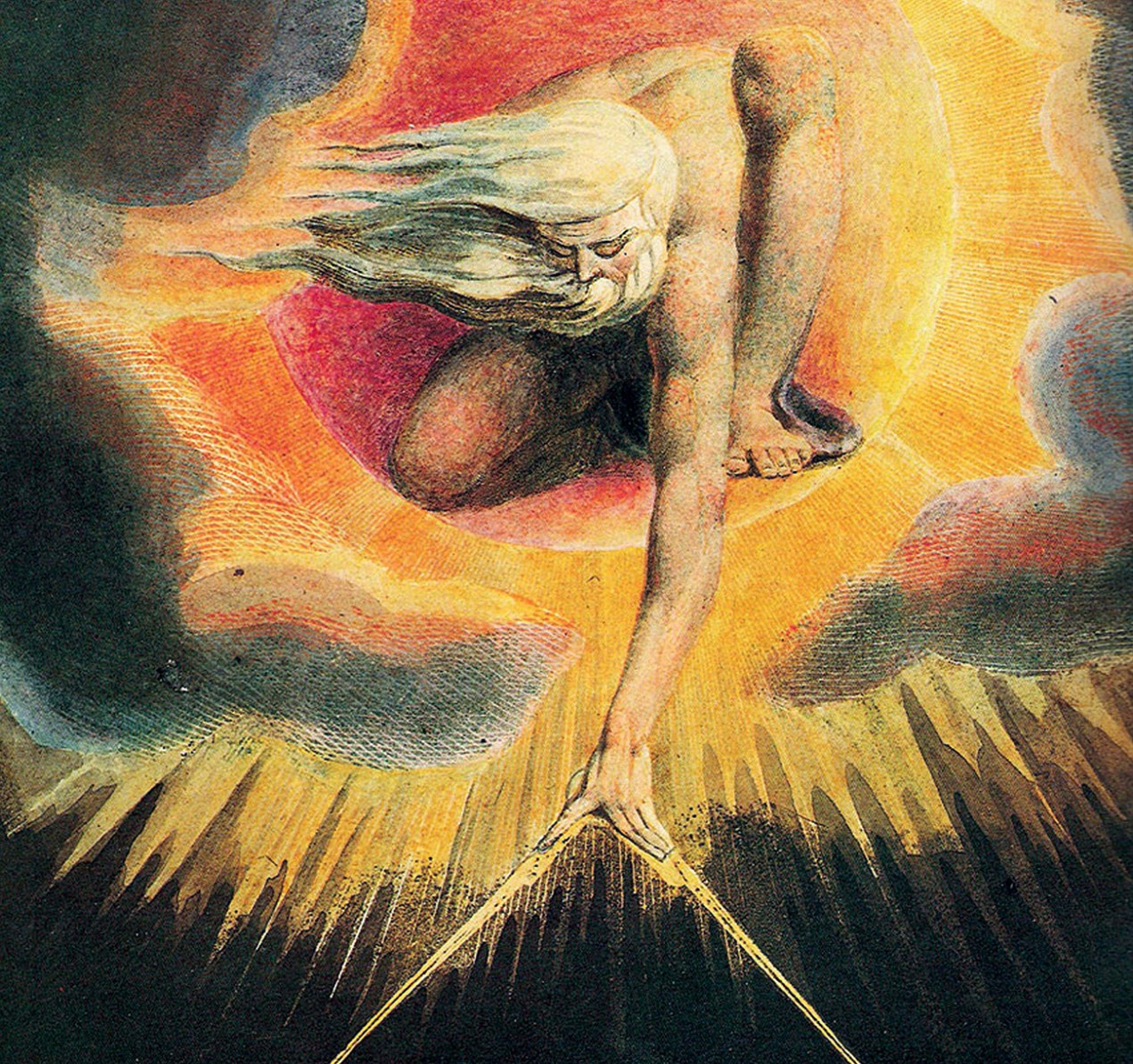Negli ultimi mesi il dibattito sui benefici dello scrivere a mano è stato animato da diverse ricerche provenienti dal settore delle neuroscienze. Come riportato anche qui, scrivere con carta e penna pare abilitare lo sviluppo cognitivo e amplificare la capacità di apprendere.
Lo studioso americano Clive Thompson, autore del best-seller tecnofilo Smarter Than You Think (2013), prova a confrontare scrittura a mano e a computer, in cerca di qualche pregio da attribuire anche alla seconda modalità di produzione di testo. Quanto Thompson mette in luce in un articolo su «Medium» è che, se la scrittura a penna vince a mani basse quanto si tratta di memorizzare e assorbire conoscenze, la tastiera del computer regna sovrana se si parla di produrre nuovi contenuti.
Il punto non è semplicemente battere sui tasti, ma saperlo fare ad alta velocità. Diversi studi dimostrerebbero che esiste una stretta connessione tra capacità di ragionamento e velocità nel mettere nero su bianco quanto pensato. In buona sostanza, pensare “veloci” serve a poco se non si è in grado di scrivere altrettanto rapidamente. E in questo una scrittura a tastiera ben impostata sembrerebbe battere lo scrivere a mano.
Confrontare le posizioni di Thompson con quelle dei sostenitori di carta e penna fornisce una riprova del fatto che, con qualche teoria cognitiva alla mano, è possibile dimostrare tutto e il contrario di tutto. Evitando qui di parteggiare per l’una o per l’altra fazione (si lascia al lettore prendere posizione), è il caso di notare che, tanto per la scrittura a mano quanto per quella a tastiera, si tratta di utilizzare al meglio gli strumenti a propria disposizione, rendendoli estensione del proprio corpo e dunque veicoli di istanze creative e comunicative. A questo proposito, si dice che il trombonista jazz J.J. Johnson fosse solito ripetere ai suoi allievi:
«Qualsiasi idea che non sei grado di tirar fuori dal tuo strumento non ha nessun valore in questa musica».
Raffrontare un mezzo per antonomasia “creativo” come lo strumento musicale con oggetti quotidiani come la penna e la tastiera potrebbe sembrare fuorviante, ma a ben vedere aiuta a realizzare che la questione centrale per qualsiasi strumento è acquisire una perizia tecnica adeguata ai messaggi che si intende veicolare. Pochi fra noi hanno velleità da trombonisti, ma siccome tutti pretendiamo ogni giorno di esprimerci battendo sui tasti di una tastiera, forse è il caso di dedicare qualche sforzo al cercare di farlo meglio.
Compito a casa: imparare a scrivere senza guardare la tastiera. E, se avanza tempo per un vezzo retrò, frequentare un corso di calligrafia.
[ illustrazione: fotogramma dal film Populaire (2012) di Régis Roinsard ]