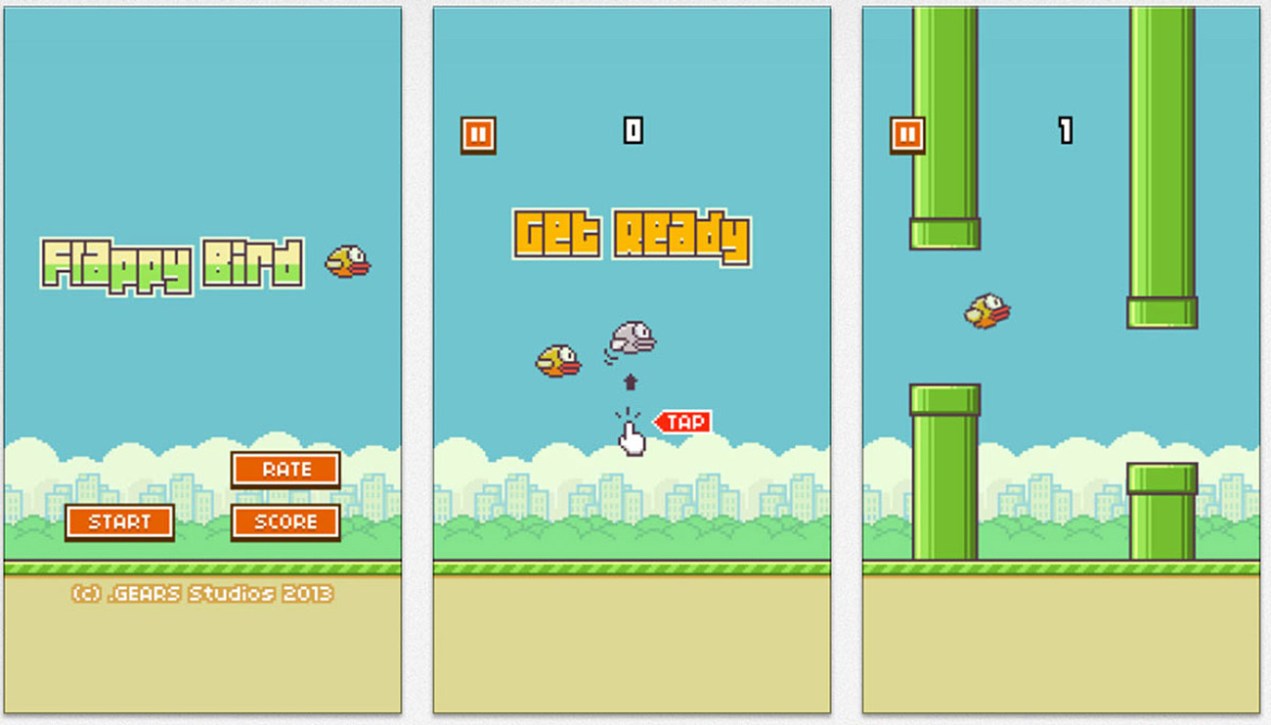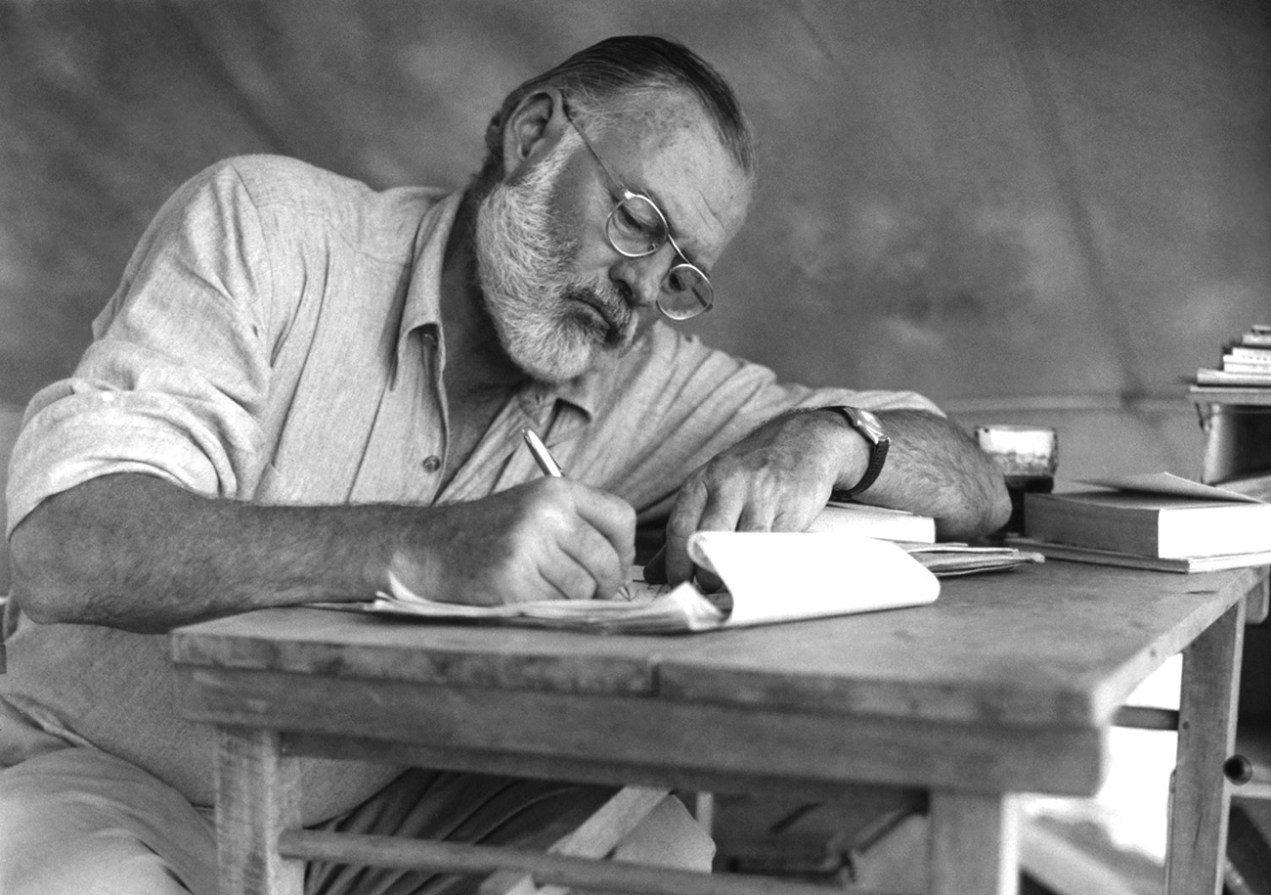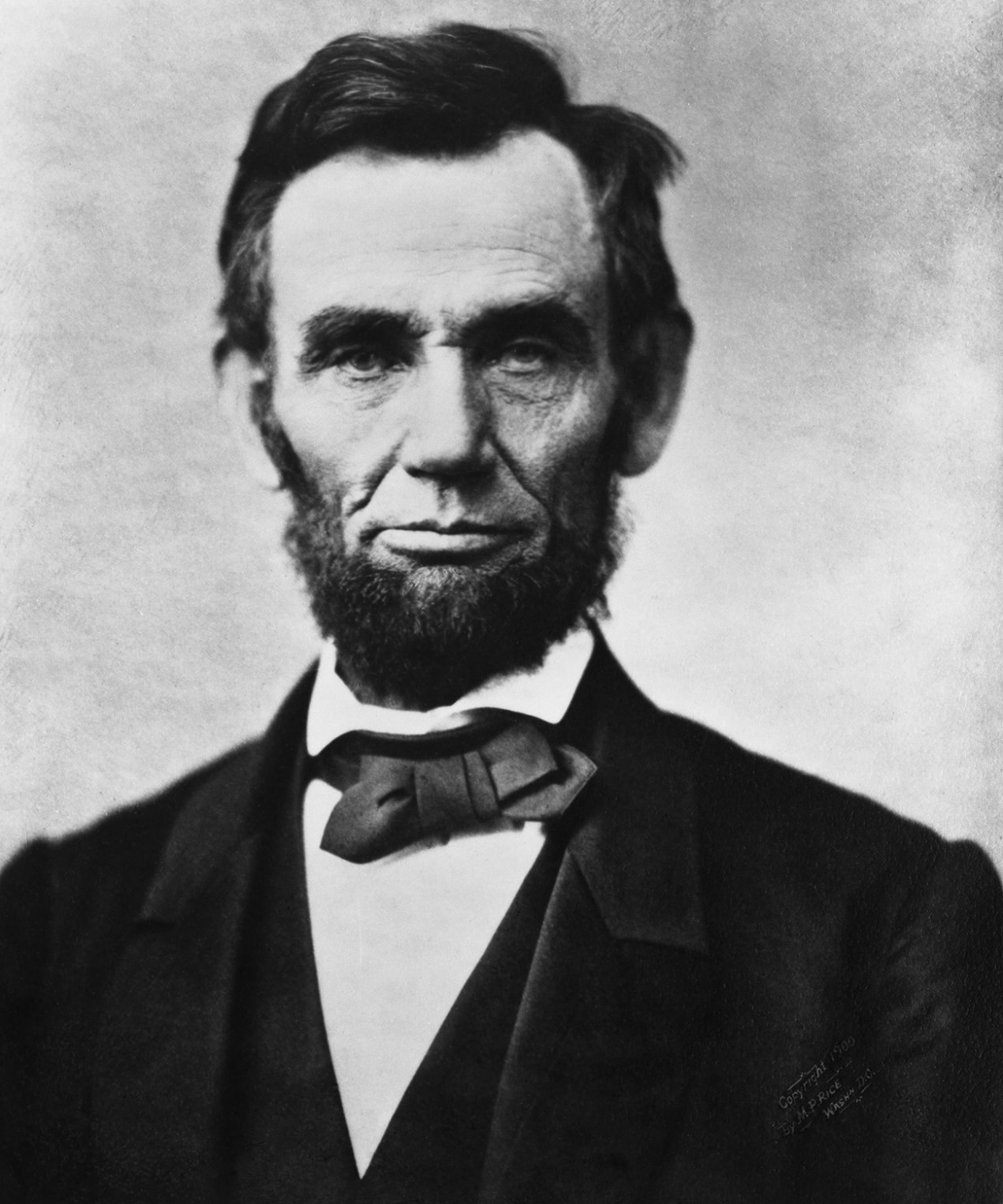Flappy Bird è una app per smartphone lanciata nel maggio 2013 da un 29enne sviluppatore vietnamita di nome Dong Nguyen. L’app in questione è un videogioco la cui banalità va di pari passo con la capacità di generare frustrazione e dipendenza. Nonché di diventare il videogioco più scaricato su smartphone, in grado di fruttare al suo creatore – nonostante la gratuità dell’app – ben $50.000 al giorno in pubblicità. Più di un sospetto è stato generato dalla velocità con cui il gioco, unanimemente valutato dagli addetti ai lavori come mediocre (nonché copia carbone di una simile app del 2011), è diventato popolare.
Un articolo tratto dal blog Eurogamer ricostruisce con cura la parabola del successo di Flappy Bird, soffermandosi sul probabile ruolo cruciale svolto in essa da “bot” e utenti “comprati” per effettuare scaricamenti e lasciare commenti positivi. Valutare quanto spregiudicata possa essere stata l’opera di promozione dell’app è in ogni caso difficile. Di certo, per usare le parole dell’articolo (che si rifà a sua volta a uno scritto dell’Independent):
«Flappy Bird è diventato il Gangnam Style dei giochi mobile: una roba talmente brutta e incomprensibile da diventare rapidamente divertente e virale».
Il paragone rende l’idea della “cifra stilistica” del videogame, il cui successo potrebbe dunque essere frutto tanto di scaricamenti comprati quanto del basso livello critico dell’utente di videogiochi medio. O più realisticamente della combinazione dei due fenomeni, il che rappresenta un duro colpo per un’accoppiata ben più classica e ortodossa, quella cioè fra creatività e meritocrazia. Lo lezione è dura da accettare: Flappy Bird mostra che nel mondo delle app, più in generale in quello dell’innovazione di prodotto, i valori tradizionalmente messi al centro dell’idea di progetto – spesso anche con una certa retorica – sono cosa passata, buona per idealisti, nostalgici o teorici ma non per chi intenda davvero raggiungere il successo.
L’epilogo della vicenda è stato decretato dallo stesso Dong Nguyen, il quale ha deciso in data 09.02.2014 di ritirare il gioco dai vari app store. Nel suo account Twitter si dichiara provato dal troppo successo e preoccupato per la dipendenza generata dall’app in moltissimi giocatori. Questo esito rende ancora più curiosa la vicenda, che assume il tono di apologo morale: che Nguyen abbia messo in piedi l’intero progetto per impartire un paio di lezioni sulle moderne tecniche di marketing e sulla sociologia dei consumi? A proposito: ora che la app non è più scaricabile, su ebay c’è perfino chi vende, fra il serio e il faceto, il proprio smartphone con Flappy Bird installato.
[ illustrazione: screenshot tratti dalla app Flappy Bird ]