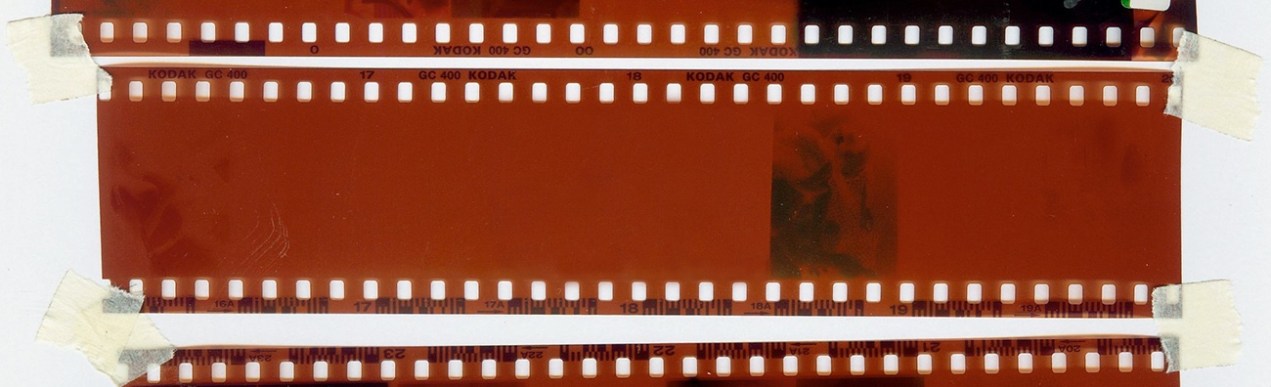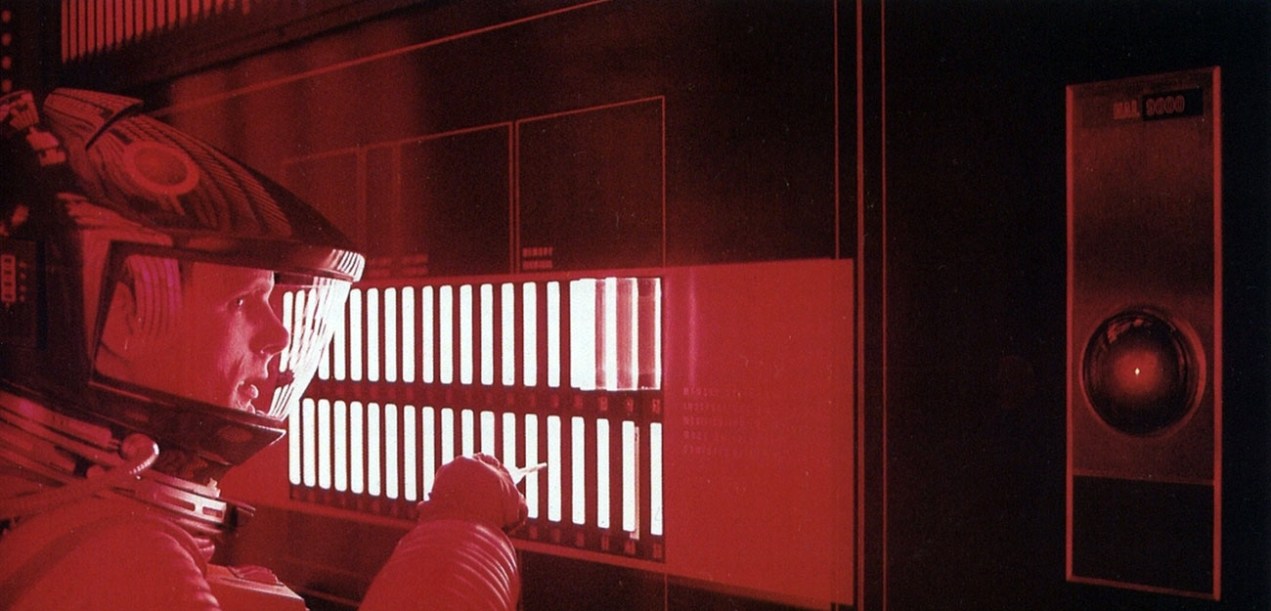Fra i casi business più interessanti degli ultimi anni spicca un confronto, quello fra due “big” dell’industria fotografica: Kodak e Fujifilm.
Nel 1881 l’imprenditore americano George Eastman (1854-1932) fonda a Rochester (stato di New York) la sua azienda produttrice di pellicole fotografiche e nel 1888 lancia il primo apparecchio Kodak (neologismo senza significato che suona bene in tutte le lingue), che viene venduto carico di pellicola e accompagnato dal celebre slogan “you press the button, we do the rest”. Facciamo un salto di qualche anno e spostiamoci dall’altra parte del mondo: nel 1932 nasce a Tokyo Fujifilm Photo Film Co. , inserendosi da subito nel mercato delle pellicole fotografiche per uso domestico e iniziando a produrre fotocamere dal 1948.
Kodak e Fujifilm possono essere considerate aziende competitor a livello paritario (ognuna con le proprie pellicole caratterizzanti e “best seller”) per lo meno fino al 1975. Questa data è estremamente importante per la storia della fotografia perché segna la messa a punto da parte di Kodak, nella persona dell’ingegnere Steven Sasson, della prima macchina fotografica digitale della storia. L’enorme potenziale competitivo offerto dall’invenzione non venne tuttavia capitalizzato a dovere da Kodak, che aspettò il 1991 per mettere sul mercato la gamma DCS di dorsi digitali dedicati ai fotografi professionisti, facendosi battere sul tempo da Sony con la sua Mavica del 1981.
Dagli anni ’90 a oggi, è nel segno del digitale che si è giocato il destino delle principali aziende fotografiche. Nel caso di Kodak, gli esiti sono noti: l’azienda ha dichiarato bancarotta nel corso del 2012 ed è oggi in una difficoltosa fase di rinnovamento. Il suo fallimento è stato causato dall’incapacità di inserirsi a dovere – nonostante l’invenzione del 1975 – nel mercato digitale, di cui non ha mai realmente saputo cogliere le potenzialità. Al caso Kodak si applica molto bene la parabola della “rana bollita”, resa celebre dal guru del pensiero sistemico Peter Senge nel suo La quinta disciplina (1990). L’incapacità dell’azienda di leggere i segnali deboli di un contesto business in lento ma inesorabile cambiamento, unita alla sicurezza conferitale dai successi per lunghissimo tempo ottenuti dal suo core business, ne ha segnato l’inevitabile declino.
Altrettanto interessante – in questo caso in chiave positiva – l’approccio al cambiamento agito da Fujifilm. Anzitutto, l’azienda ha saputo cavalcare l’onda del digitale grazie a una strategia distintiva che l’ha condotta a essere oggi più che competitiva nel settore delle compatte prosumer, giocando sul rapporto tra soluzioni tecnologiche innovative ed estetica retrò. Ancora più significativa è stata la scelta di Fujifilm di convertire asset e tecnologie legate alla produzione delle pellicole – attività ormai ridotta pressoché a zero – a un mercato del tutto inaspettato e lontano dal core business dell’azienda: quello della cosmetica. È così nata, a partire dal 2007, la produzione di Astalift, brand di prodotti di bellezza facente capo alla holding Fujifilm e distribuito in tutto il mondo. Questa brillante svolta aziendale, basata su una expertise in tema di collagene e antiossidanti maturata in oltre 70 anni di attività, dimostra la destrezza con cui l’azienda ha saputo evitare di finire “bollita” innovando grazie a una lungimirante riconversione delle proprie risorse.
[ illustrazione: pellicola Kodak, foto di paperplanepilot ]