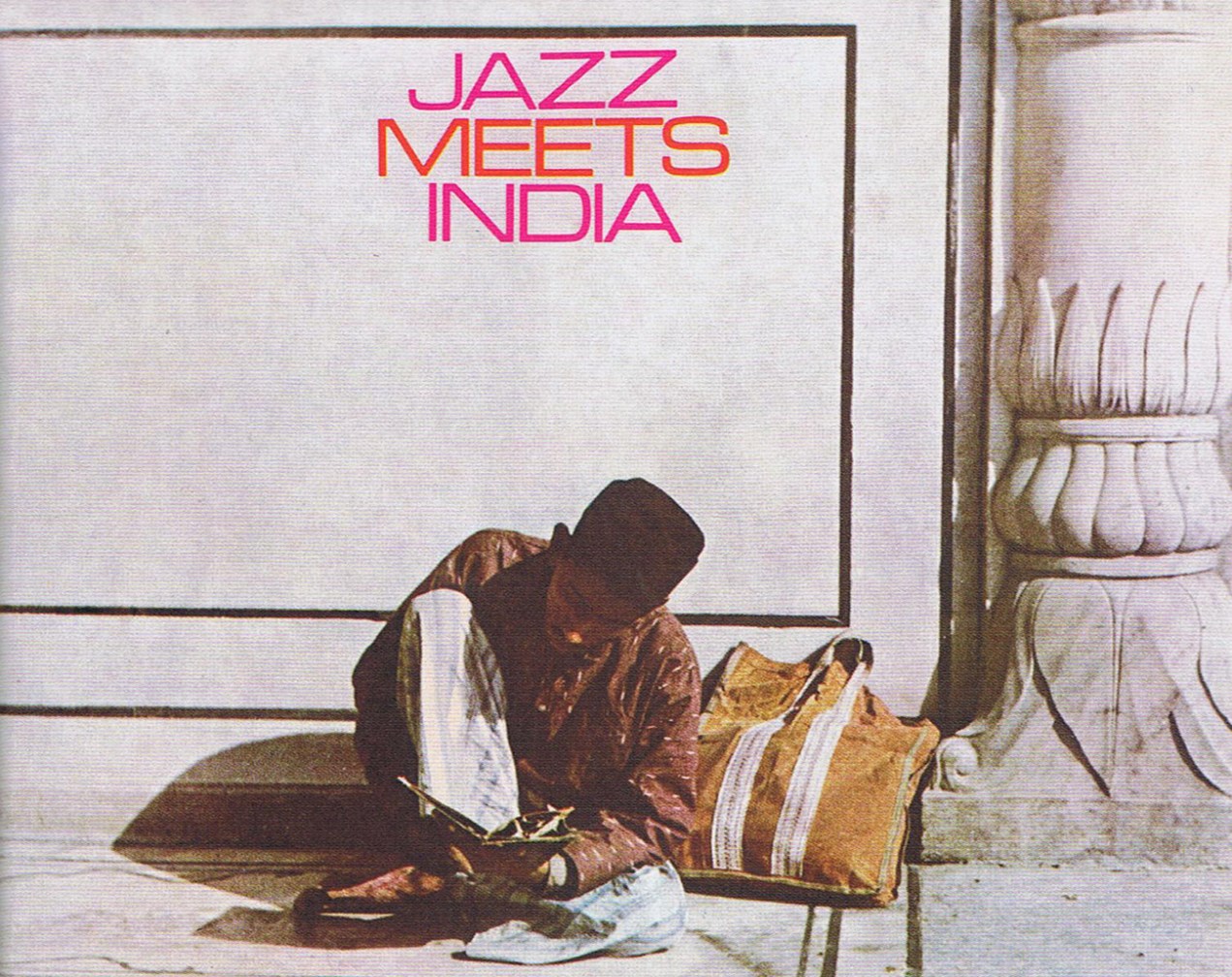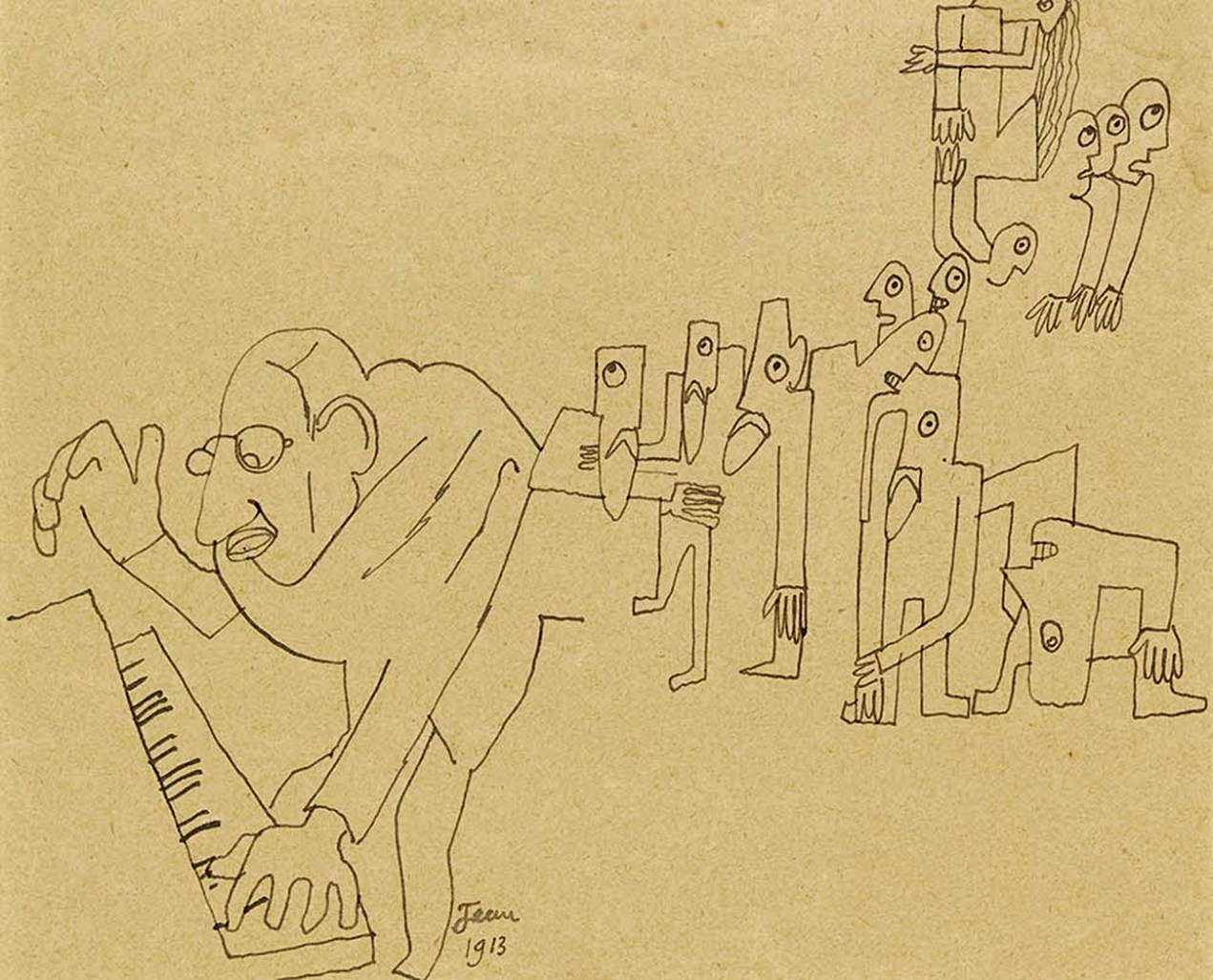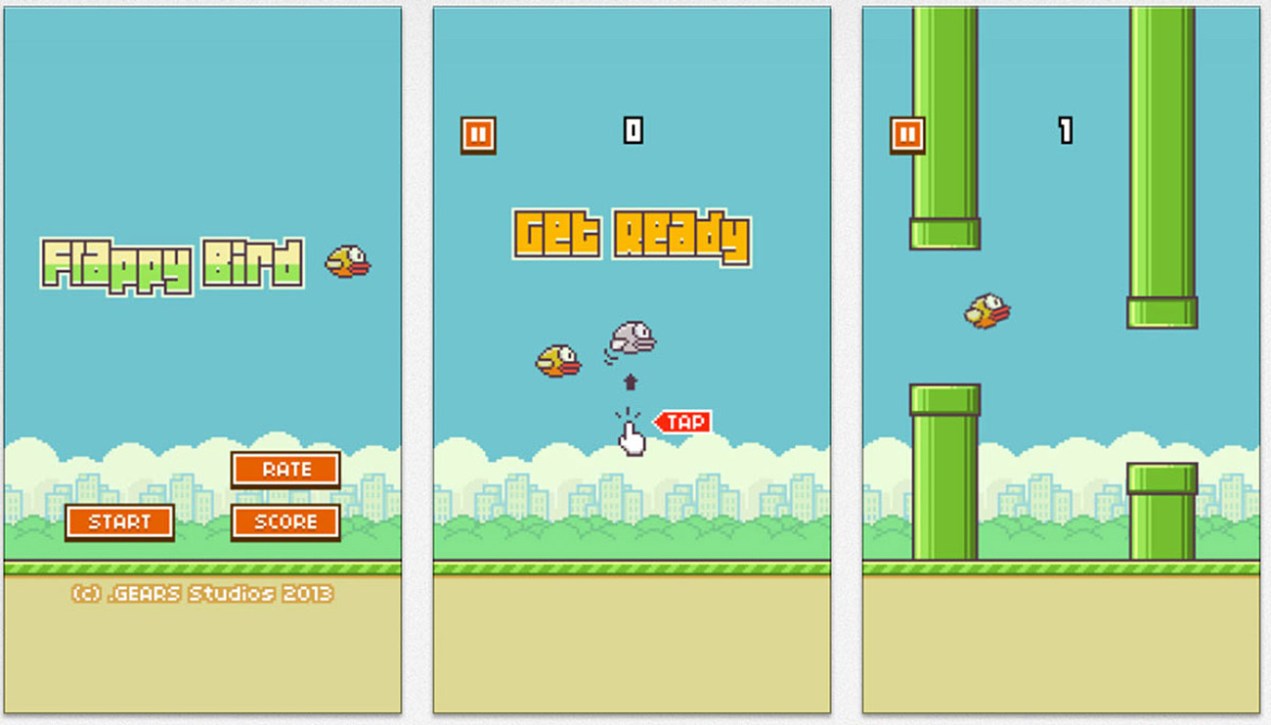«Mai è esistito un uomo più fotografato. Mai la fotografia è stata una risorsa tanto importante per gli affari nazionali, e mai una dittatura si compiace di un’autenticità maggiore».
È di Mussolini che si parla e a descriverlo così è lo scrittore austriaco Joseph Roth (1894-1939), per l’occasione nelle vesti di inviato del quotidiano «Frankfurter Zeitung». Nei suoi scritti sull’Italia fascista (una cui selezione è raccolta in La quarta Italia, 2013) lo sguardo di Roth restituisce, oscillando tra senso del tragico e del clownesco, una lucida e impietosa descrizione del ventennio nella quale atteggiamenti infantili e violenti risultano inscindibilmente connessi. L’articolo da cui la citazione è tratta è del 1928 e il suo titolo è Dittatura in vetrina.
I ritratti di Mussolini, nota Roth, sono ovunque: in tutte le vetrine di caffè o ristoranti, così come in ogni casa privata. Osservando queste miriadi di immagini si nota come Mussolini abbia fatto propri gesti e comportamenti fino a quel momento riservati alle autorità nobiliari, come l’elargire e ricevere saluti o l’avanzare con solennità in mezzo alla folla. Nel campionario mussoliniano mancano tuttavia, nota Roth, i gesti del quotidiano e del triviale, che potrebbero scalfire l’immagine tanto perfetta quanto artificiosa costruita per il dittatore: Mussolini non sbadiglia mai, non si toglie mai il panciotto?
Attraverso le ironiche parole di Roth, il falso ottimismo costruito ad arte dalla propaganda fascista emerge in tutta la sua vacuità. In particolare, è in primo piano l’uso da manuale del medium fotografico, che annulla la differenza tra rappresentazione e realtà facendo sì che anche le apparizioni in pubblico del duce diventino una sorta di illustrazione anticipata, un materiale grezzo già pronto per una rivista patinata.
[ illustrazione: scheda di arresto di Benito Mussolini da parte dell’autorità svizzera (con l’accusa di vagabondaggio e istigazione allo sciopero), giugno 1903 ]