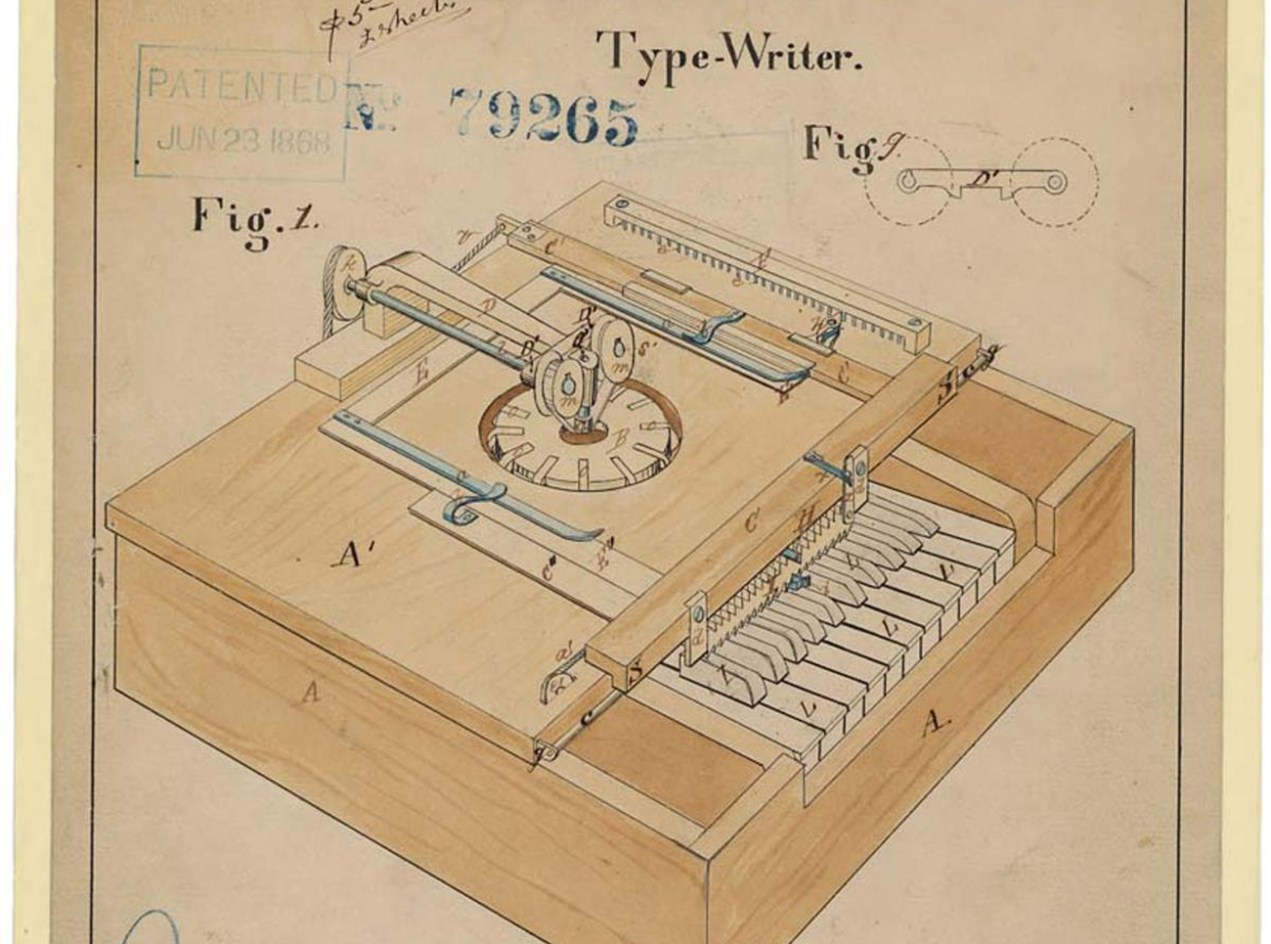Paolo Legrenzi, Docente di Psicologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, esplora nel suo Frugalità (2014) un concetto che in tempi di crisi gode di particolare popolarità. Ma cosa significa essere frugali? Assumendo il punto di vista dello psicologo, la frugalità è un atteggiamento generale di fronte alla vita, una scelta di stile e buon gusto che poco o nulla ha che fare – come ha sostenuto Bruno Munari in Da cosa nasce cosa
(1981) – con il lusso. La frugalità, nota Legrenzi, non è uno strumento orientato a uno scopo; deve essere coltivata come un fine in se stessa. Non si tratta, come nel caso della povertà, di una costrizione, ma del risultato di una libera scelta. Essere frugali significa rifiutare l’abbondanza e il superfluo, concentrandosi sull’essenziale.
Un simile approccio alla frugalità si distanzia fortemente da quello assunto dalla maggior parte dei libri di business orientati a questo tema. Come citato in apertura, se oggi si parla tanto di frugalità è principalmente a causa del generale contesto di crisi e della diffusa percezione di scarsità. Soprattutto per quanto riguarda le aziende, vissute per lungo tempo in un ambiente di abbondanza di risorse, ricorrere alla frugalità è oggi più un obbligo che una scelta. Proprio come lo è l’imparare a improvvisare per chi si è cullato per anni nella credenza che i piani possano essere immutabili e impermeabili ai cambiamenti di contesto.
La maggiore utilità del libro di Legrenzi è dunque questa: offrire un convinto paradigma di vita orientato alla frugalità a chi inizia solo ora a confrontarsi con questa parola. Benché l’autore sembri guardare i nuovi adepti dall’alto al basso (la frugalità è un sapere tacito che si impara da piccoli in famiglia, non una nozione che si apprende a scuola – sostiene Legrenzi), nelle ultime pagine di Frugalità (2014) stila un decalogo il cui senso può essere sintetizzato in una parola: autocontrollo.
[ illustrazione: Giuseppe Vermiglio, S. Paolo Eremita, circa 1649 ]