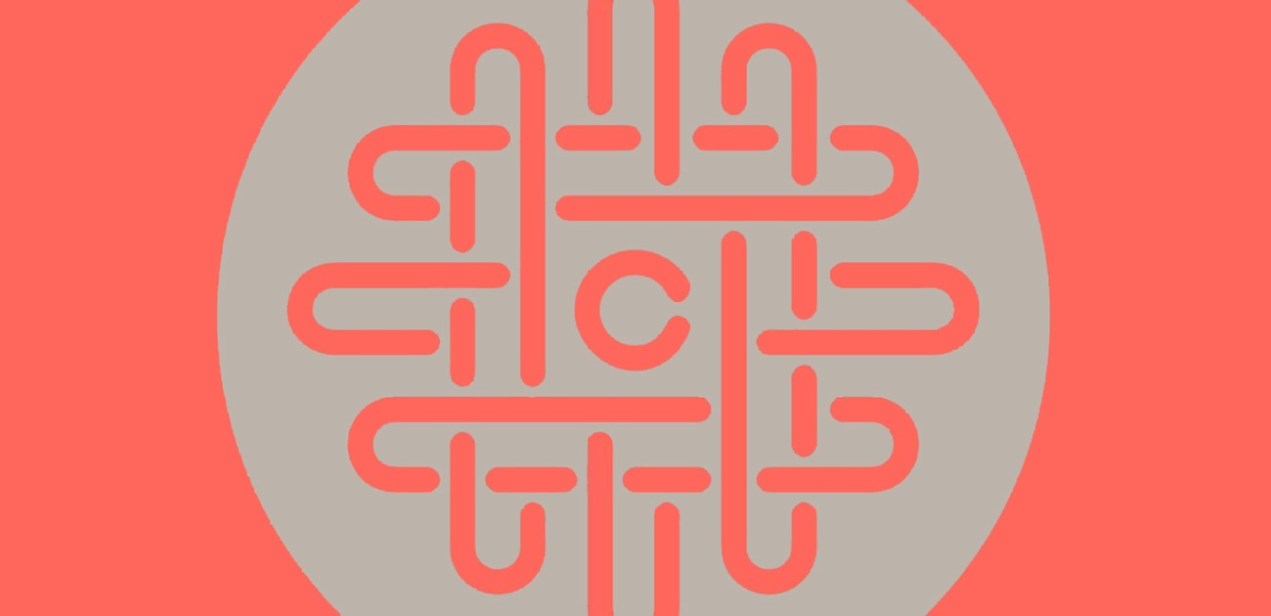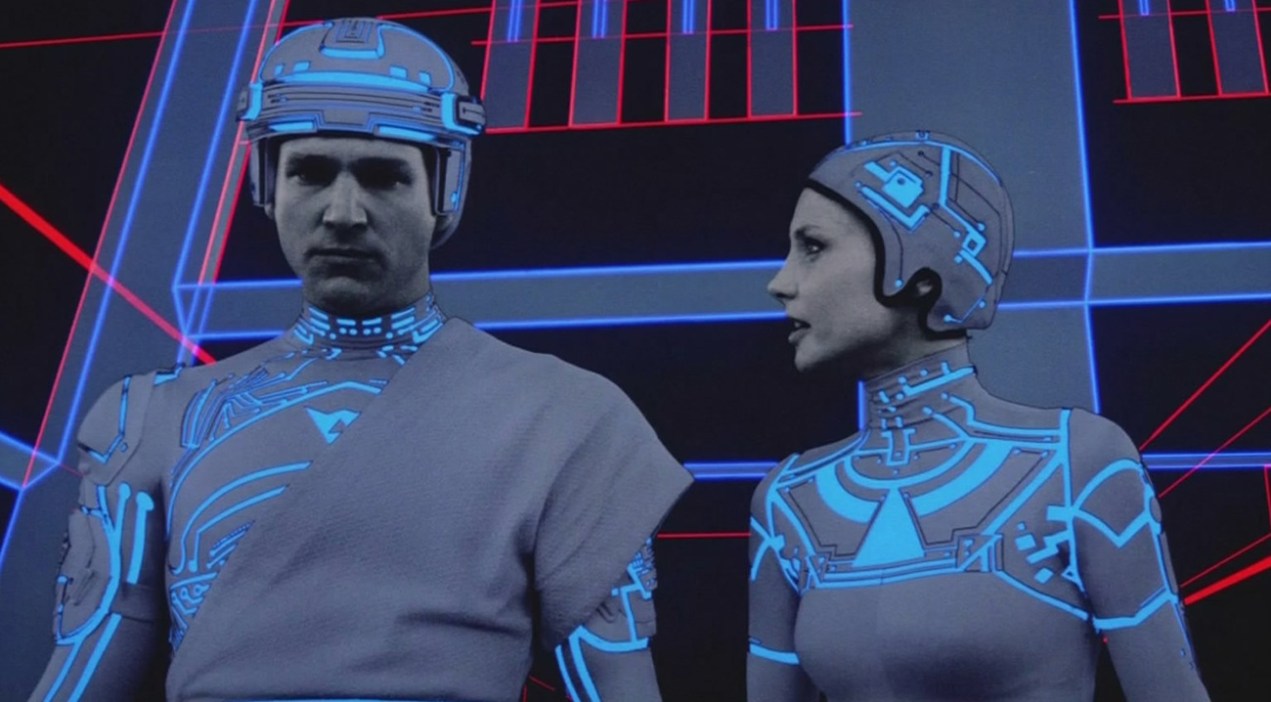«But my point is, what if we all behaved as if we were being watched? It would lead to a more moral way of life. Who would do something unethical or immoral or illegal if they were being watched?»
Così si esprime uno dei personaggi principali di Il cerchio (2013) di Dave Eggers. Pur non contraddistinto da grande valore letterario, il romanzo rappresenta una puntuale riflessione sulla direzione in cui lo sviluppo delle tecnologie “social” ci sta conducendo, sia dal punto di vista della creazione di monopoli economici (su tutti: Google e Facebook) che da quello della tutela della privacy. Quanto Eggers descrive nel suo libro ha ben poco di fantascientifico e potrebbe tranquillamente realizzarsi nel giro di pochi anni.
Un sotto-tema che emerge con forza dal testo è quello dei “big data”, intesi tanto come strumento di personal tracking quanto come risorsa economica a disposizione dei colossi informatici. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’enorme potere delle informazioni aggregate rappresenta un inedito strumento di controllo che si sta progressivamente concentrando nelle mani di pochi decisori. Le riflessioni di Eggers qui si avvicinano molto a quelle di uno dei più attenti osservatori dei fenomeni mediatici, cioè Evgeny Morozov.
Sul fronte dell’impatto dei social media sugli individui, Eggers si allinea con quanti sostengono che la tensione a controllare e rendere pubblico praticamente ogni aspetto della propria vita rischi di condurre a pericolose derive dei rapporti sociali e a nuove psicopatologie. Un interessante spunto su questo tema ha a che fare con i cambiamenti delle modalità lavorative: se quasi venti anni fa Jeremy Rifkin parlava di La fine del lavoro (1995), quanto The Circle preconizza è un abbattimento delle barriere tra vita lavorativa e privata in cui la spettacolarizzazione e pubblicità di entrambe le sfere diventa un potentissimo driver di “conversioni economiche” all’interno di qualsiasi momento dell’esistenza.
[ illustrazione: particolare dalla copertina di The Circle di Dave Eggers ]