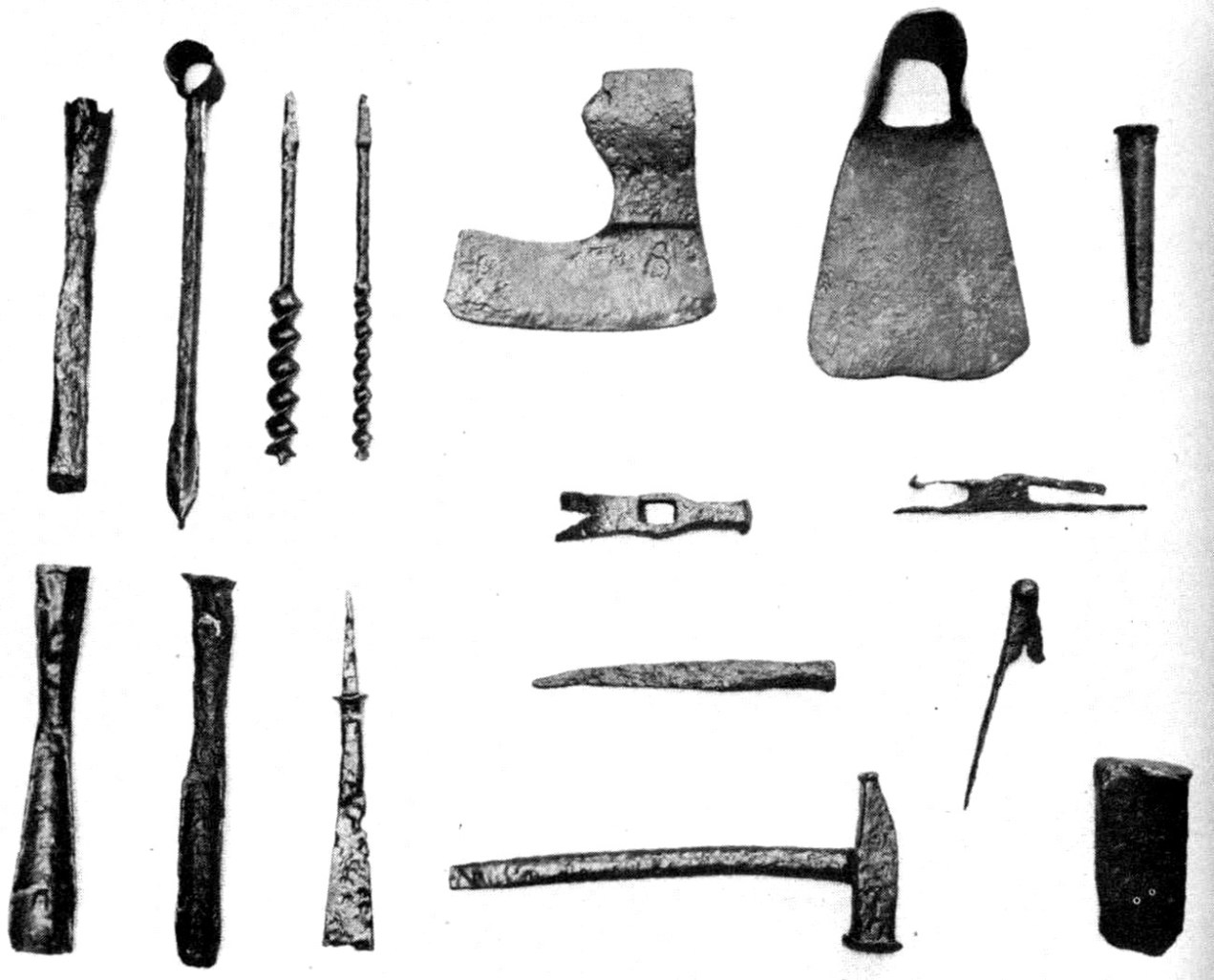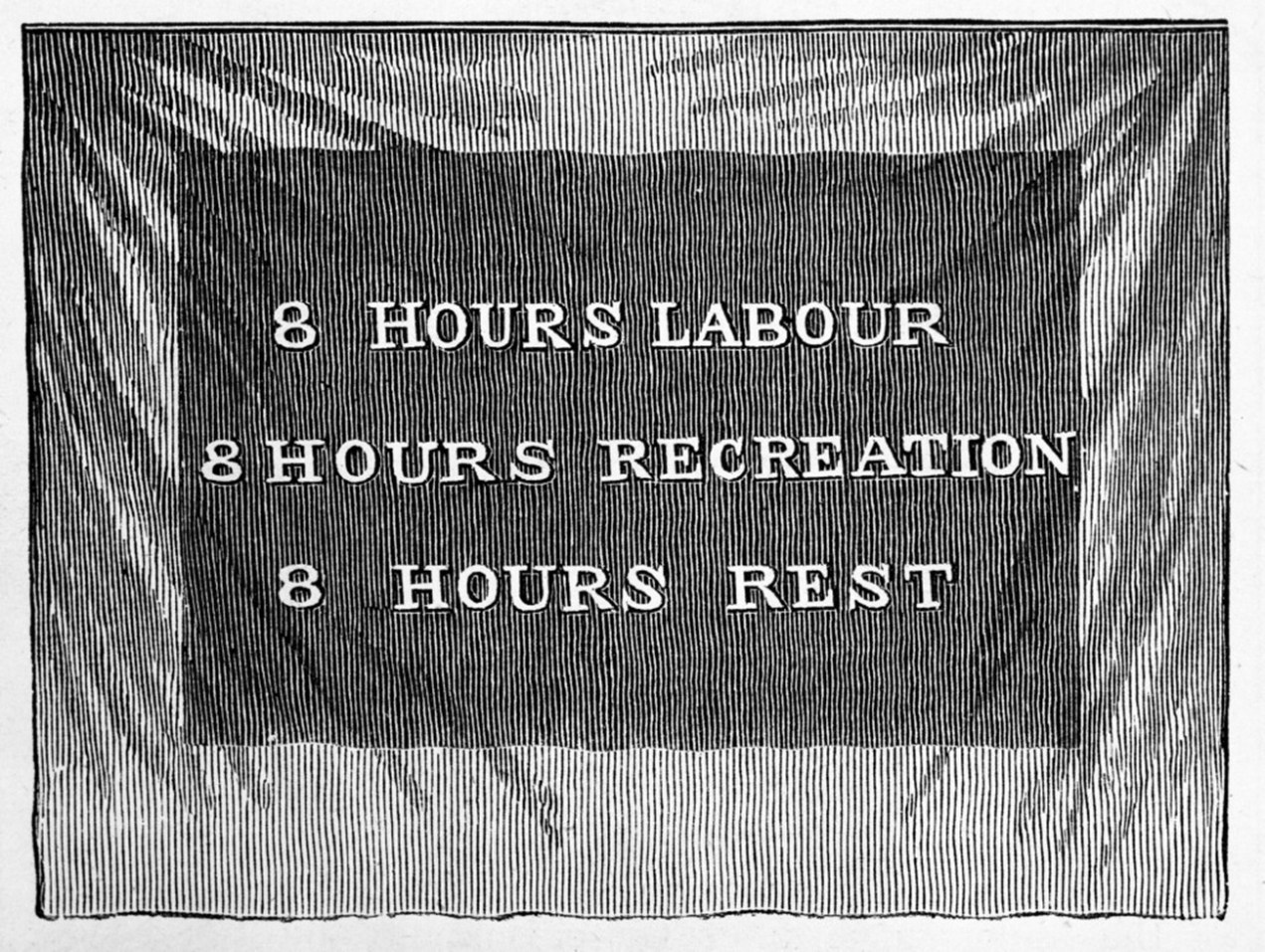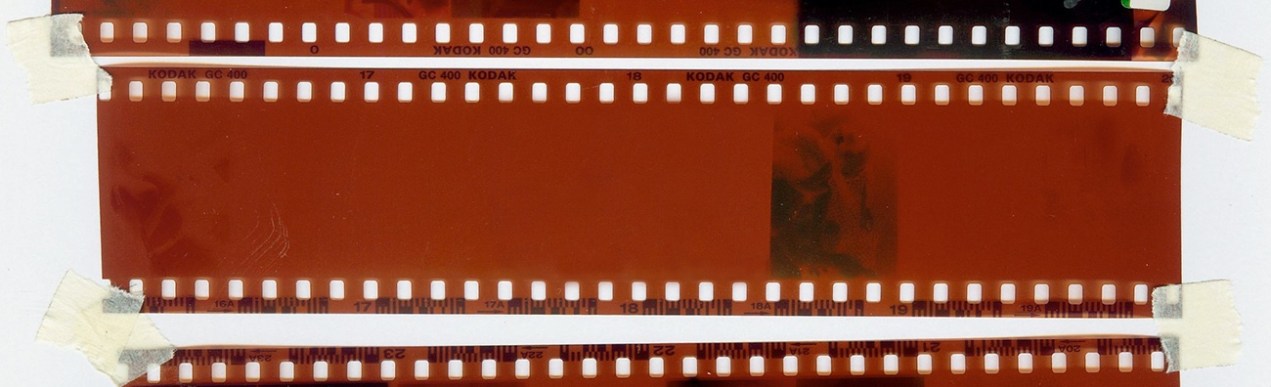Come molte grandi aziende del settore fotografico la cui egemonia si è sviluppata nell’era della pellicola ed è stata messa in discussione dall’avvento del digitale (su tutte: Kodak), anche Polaroid ha trascorso anni difficili. L’azienda ha dichiarato bancarotta nel 2001 e poi ancora nel 2009, anni in cui al suo vertice si sono avvicendati ben sei diversi amministratori delegati. Nel frattempo, l’azienda ha perso praticamente tutti i suoi asset conservandone fondamentalmente uno: il brand.
Grazie alla reputazione del proprio marchio, che ancora oggi comunica al grande pubblico i valori in esso instillati dal suo fondatore Edwin Herbert Land (1909-1991), Polaroid ha potuto stabilire una serie di accordi di licenza che hanno portato il brand ad avvicinarsi a nuovi ambiti di prodotto quali quello dei tablet e delle televisioni. Conservando la memoria affettiva dei tre principi con cui Land aveva fondato nel 1937 l’azienda, e cioè visione, condivisione e convenienza, i prodotti che oggi utilizzano il marchio Polaroid cercano – con discutibile successo – di tenere viva l’immagine di un’azienda che purtroppo non ha saputo innovare in relazione ai cambiamenti del contesto. In qualche maniera, Polaroid ha deciso di puntare sullo sfruttamento del suo patrimonio culturale e di non investire nello sviluppo del nuovo.
Per contrasto, il lavoro di Impossible Project, impresa olandese che nel 2008 ha rilevato da Polaroid i macchinari per la produzione di pellicole istantanee, rappresenta innovazione nella continuità. A fronte del completo arresto della produzione di pellicole per le macchine Polaroid, la domanda di mercato – decisamente significativa in una società prona al senso nostalgico del vintage – ha rischiato di rimanere frustrata. Con grande tempismo, Impossible Project ha rimesso in moto la produzione, costruendo una gamma mai così ampia e variegata di pellicole istantanee che, manco a dirlo, si giovano a loro volta del valore emotivo del brand Polaroid.
[ illustrazione: ritratto di Edwin Herbert Land ]